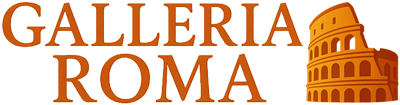Cagnaccio di San Pietro
(Natale Bentivoglio Scarpa)
Natale Bentivoglio Scarpa nasce a Desenzano il 14 gennaio 1897 e cresce nell’isola di San Pietro in Volta nella laguna veneta, luogo d’origine dei genitori manifestando fin dall’infanzia una spiccata attitudine per le attività artistiche.
Il suo percorso parte da un’inclinazione e un interesse privilegiato per l’attività plastica, a Venezia segue i corsi di Ettore Tito all’Accademia di Belle Arti e, intorno al 1911, il futurismo allora nascente lo coinvolge con la sua portata innovativa e ricca di stimoli. La vicenda drammatica della guerra segna una profonda linea di demarcazione tra un prima e un poi modificando definitivamente la sua visione del mondo, un’esperienza estrema che investe tutto l’ambiente artistico di quel periodo. Nel 1919 partecipa insieme a Gino Rossi, Casorati, Garbari, Semeghini alla mostra di Cà Pesaro a Venezia, esponendo Cromografia musicale e Velocità di linee-forza di un paesaggio, due opere di impronta futurista. Intorno al 1920 comincia a firmare i suoi lavori con il nome di Cagnaccio con cui era conosciuto nella piccola isola di San Pietro. E del 1920 La tempesta, tema che verrà ripreso e variato nel suo ultimo dipinto, La furia, del 1945.
L’opera segna un momento importante nel percorso artistico di Cagnaccio che proprio in questi anni inizia a gettare le basi della propria originalità e impronta stilistica. La tempesta è il punto di partenza per l’evoluzione della sua ricerca che, ormai affrancatasi dall’esperienza futurista, si rivolge alla tradizione formale del Quattrocento, unendo all’attenzione per la realtà la forza trasfigurante dell’emozione. Nel 1922 espone alla Biennale di Venezia La tempesta, le sue opere, che vengono inoltre esposte alle mostre di Cà Pesaro di quegli anni, saranno presenti nelle successive edizioni della Biennale fino al 1944 e oltre.
Certamente a Cagnaccio interessa la realtà, ma sempre mediata, attraversata da quella portata emozionale che, attraverso l’arte può rivelarsi. Verso il 1925 l’artista inizia a firmarsi Cagnaccio di San Pietro. Suoi temi preferiti sono le nature morte, i bambini, il quotidiano, restituito però in chiave straniata e talvolta drammatica, con il rigore di una ricerca sempre estremamente tesa e una lucida, esasperata attenzione per il dettaglio.
È del 1928 il dipinto Dopo l’orgia, che venne rifiutato dalla commissione della Biennale probabilmente anche per la brutale chiarezza con cui veniva rivelata nei particolari dei polsini fregiati del fascio littorio, il potere corrotto del fascismo.
Cagnaccio di San Pietro un anarchico, un cane sciolto, dimostra di non voler rinunciare all’impegno morale, conditio sine qua non di tutto il suo lavoro, sostanzialmente autonomo e spesso eccentrico rispetto all’ambiente artistico del tempo segnato dalla presenza del Novecento.
Va sottolineato inoltre come Dopo l’orgia non sia formalmente troppo lontano dalle realizzazioni della Nuova Oggettività tedesca; in ogni caso Cagnaccio spinge il realismo fino alla sua dimensione più estrema e straniata, non di rado avvalendosi di tagli, rese cromatiche e punti di vista propri del mezzo fotografico. Nel corso degli anni Trenta Cagnaccio continua ad affinare gli strumenti della sua ricerca, sempre più orientata verso un misticismo e una crescente attenzione per il mondo spirituale.
Nel 1934 realizza / naufraghi, una grande tela che verrà esposta alla Biennale di Venezia nel 1935, in cui è presente una doppia componente: da una parte una presa diretta sulla realtà e dall’altra la rarefazione della realtà stessa, cifra originale che caratterizza lo stile dell’artista. Tra il 1937 e il 1938 soggiorna a Genova.
Tornato a Venezia viene ricoverato tra il 1940 e il 1941 all’ospedale del Mare del Lido: nascono così opere che affrontano direttamente e con lucidità il tema della sofferenza, sempre sottilmente sotteso al suo lavoro.
Il lavoro di Cagnaccio di San Pietro, infaticabile disegnatore e artista dalle molteplici suggestioni, viene regolarmente esposto nell’ambito di mostre personali e di rassegne pubbliche fino alla sua morte, sopraggiunta il 26 maggio 1946 a Venezia. In seguito verranno curate rassegne espositive che contribuiscono a restituire il giusto rilievo all’artista per un lungo periodo impropriamente confinato in un ruolo di secondaria importanza nel contesto culturale del suo tempo.
(DT)
Categoria: Salute e Bellezza
-

Cagnaccio di San Pietro(Natale Scarpa)
-

RAGUSA VINCENZO
Ragusa Vincenzo (Palermo,1841-1927)
Scultore e pittore. Ottenne nel 1876 un posto di insegnante all’Accademia di Belle Arti di Tokyo e rimase in Giappone per sei anni. Ivi lavorò e si sposò una giapponese. Nel 1884 partecipò alla Promotrice di Torino.
-

LENTINI ROCCO
Palermo 27 Febbraio 1858 – VE,20 Novembre 1943
Personaggio sicuramente non secondario nel vivace ambiente culturale ed artistico di Palermo a cavallo tra Ottocento e Novecento. Figlio di Giovanni, scenografo, suo primo maestro. Nel 1877 vinse una borsa di studio del Comune di Palermo che gli permise di continuare gli studi all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Fu anche a Parigi dove espose al Salon del 1879 e dove potè approfondire la sua formazione Nel 1879 partecipò alla Promotrice di Torino. Rientrato in Italia vinse, nel 1884, il concorso per la cattedra di Pittura dell’Accademia di Brera e si fermò per qualche anno a Milano. Tornato a Palermo iniziò la sua lunga carriera di insegnante, che si concretizzò anche in due pubblicazioni: Elementi di Ornato (1892) ed Elementi di Paesaggio. Frutto importante dei suoi studi sull’arte in Sicilia fu l’attiva collaborazione alla realizzazione, nel 1911, del volume di Ernesto Basile Le sculture e gli stucchi di Giacomo Serpotta. In quegli anni partecipò alle imprese decorative più importanti realizzate a Palermo. Organizzò anche la I Mostra Siciliana di Pittura, Scultura, Bianco e nero, tenuta a Villa Gallidoro, presentandovi pure tredici dipinti. Partecipò attivamente alla vita culturale della città anche come direttore e proprietario della rivista mensile “La Sicilia Artistica e Archeologica”, continuando tuttavia a mantenere rapporti costanti con altri centri artistici. Furono frequenti i suoi viaggi in Germania, nel nord Italia e, soprattutto, a Venezia dove partecipò a due Biennali, del 905 e del 1922, e dove rimase fino alla morte.
Dipinse molti paesi e marine rappresentanti luoghi della Sicilia. Tra le molte opere ricordiamo: Lo sbarco di Garibaldi a Marsala, notevole per la diligente ricostruzione dello storico avvenimento, L’Alabardiere, firmato e datato 1879, Porto oggi conservato nella Galleria d’Arte Moderna di Palermo.
Sue le Decorazioni del Teatro Massimo e del Politeama Garibaldi (PA) .