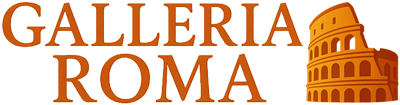Sì accede all’anfiteatro tramite un viale che attraversa un giardino, partendo dal piazzale antistante la chiesa di S. Nicolo Lungo il viale sono disposti numerosi sarcofagi in pietra, provenienti dalle necropoli di Siracusane di Megara Iblea. L’edifìcio è orientato obliquamente rispetto al teatro, che si adegua all’orientamento della Neapolis. Come l’Ara di Ierone (con una leggera declinazione rispetto a questa) l’anfiteatro sembra allinearsi in conformità all’impianto di Acradina, in senso nord-ovest/sud-est; probabilmente esso era condizionato da vie più antiche, provenienti da sud, dove infatti si trovava l’ingresso principale. L’anfiteatro era in gran parte scavato nella roccia, se si esclude il lato sud. La parte alta, di cui non resta praticamente nulla, era invece costruita. Le dimensioni sono ragguardevoli (140×119 m), superiori a quelle degli altri due anfiteatri siciliani (Catania e Termini Imerese).
L’arena è chiusa tutt’intorno da un alto podio, dietro il quale corre un corridoio anulare coperto a volta (crypta). Su di questo poggia la prima serie di gradini, destinata agli spettatori di riguardo, i cui nomi erano iscritti, in corrispondenza dei posti loro assegnati, sulla balaustra marmorea del parapetto (alcune di queste iscrizioni, di epoca tarda III -IV secolo sono ancora conservate sul posto). Seguiva, dopo un corridoio, l’ima cavea, la sola in parte conservata, mentre della media cavea e della summa cavea restano solo le fondazioni. L’anello superiore si concludeva con un portico, alcune colonne del quale sono conservate ai piedi del podio. Un complesso sistema di gradinate permetteva di accedere ai vari ordini di posti. Due grandi corridoi, con rami laterali, davano accesso all’arena (69,80×31,60), al centro della quale è scavato un ampio sotterraneo (15,50×8,70, profondità m 2,50), in origine coperto da un impiantito ligneo, nel quale si entrava da un corridoio proveniente da sud: si trattava di un sotterraneo utilizzato per i macchinari destinati agli spettacoli, di un tipo che si ritrova in tutti gli anfiteatri minori, non dotati, come il Colosseo, di sotterranei più ampi e complessi.
Verso l’ingresso meridionale,.il principale, convergeva l’importante asse viario che divideva l’Acradina dalla. Neapolis, e che si concludeva poco prima dell’anfiteatro, con un arco onorario di età augustea, del quale si sono trovati i basamenti. “Dal piazzale antistante si scendeva verso l’ingresso sud tramite un sistema di ampie scalee: a nord di queste sono i resti di una grande fontana, contemporanea all’anfiteatro. L’approvvigionamento idrico era ga- rantito da una grande cisterna a tre navate su pilastri, ancora conservata sotto la vicina chiesa di S. Nicolo.
La cronologia dell’edifìcio è stata discussa, ma non vi è dubbio che esso sia stato realizzato subito dopo la deduzione della colonia augustea, negli ultimi decenni del I sec. a. C. Ciò risulta dalla tecnica edilizia (che utilizza l’opera reticolata, e archi a conci piuttosto allungati) e da un frammento della grande iscrizione dedicatoria, dai bei caratteri augustei, che menziona uno dei magistrati realizzatori dell’edifìcio, un Betilieno che, a giudicare dal nome, dovrebbe essere originario di Alatri. Valerio Massimo ricorda uno spettacolo gladiatorio avvenuto a Siracusa (certamente nell’anfiteatro) e l’importanza di questi munera gladiatori per la città è confermata da un senatoconsulto emanato sotto Nerone, nel 58 d. C., che autorizzava i Siracusani a superare il numero di gladiatori normalmente permesso .
Categoria: News
-

ANFITEATRO ROMANO
-

ARA DI IERONE II
Parlando della prosperità della Sicilia nel periodo di Timoleonte e in quello immediatamente successivo, Diodoro ricorda gli edifìci più importanti allora costruiti a Siracusa: tra questi cita due monumenti dovuti a Ierone II: l’Olympieion presso l’agorà e l’altare presso il teatro, che era lungo uno stadio e alto e largo in proporzione. Siamo così in grado di identificare senza possibilità di dubbio l’Ara di Ierone II nel lunghissimo basamento, del quale rimane quasi solo la parte intagliata nella roccia, ancora visibile circa 100 m a sud-est del teatro. Si tratta di un nucleo ricavato dalla roccia (la parte costruita fu demolita dagli Spagnoli nel XVI secolo) lungo 198,40 m, misura che corrisponde approssimativamente alla lunghezza di uno stadio olimpico (192 m), confermando così l’affermazione di Diodoro. La larghezza massima era quella della testata nord (22,60 m), che costituiva uno dei due ingressi (insieme all’opposta testata sud) alla piattaforma superiore. L’ingresso della rampa nord era fiancheggiato da due telamoni: restano i piedi di quello di destra. È possibile che all’altare appartenga anche la statua di satiro, anch’essa con funzione di telamone, trovata nei paraggi e conservata al museo di Siracusa (non è escluso però che essa appartenga al teatro, come l’altra rappresentante una menade.
L’ampia piazza a ovest dell’altare era circondata su tre lati da un portico allungato, costituito da 14 colonne sui lati brevi e da 64 sul lato lungo; questo era interrotto al centro da un propileo. In mezzo alla piazza era una grande vasca, con al centro un basamento, probabilmente destinato a sostenere una statua. Un canale di drenaggio costruito in blocchi si distacca dalla vasca, attraversando il portico. Numerose cavità sulla superfìcie del piazzale erano probabilmente destinate a ospitare alberi: l’area era dunque occupata da un giardino. Il portico, che sostituisce una più antica strada incassata nella roccia (nella quale erano ricavate numerose nicchie votive), fu aggiunto all’altare in un secondo tempo (forse in età augustea). Ignoriamo a quale divinità fosse dedicato l’altare, che è il più grande conosciuto del mondo greco. Si è pensato a Zeus Eleutherios (« liberatore »), al quale, dopo l’espulsione nel 466 dell’ultimo dei Dinomenidi, Trasibulo, fu dedicata una statua colossale, in onore del quale veniva celebrata la festa delle Eleutheria, con il sacrifìcio di 450 tori (Diodoro, XI 72, 2): le dimensioni del sacrifìcio spiegherebbero quelle dell’Ara. -

CASTELLO MANIACE
Fin dai più antichi tempi di Siracusa l’estremo sperone roccioso concludente sul mare Ortigia fu sede di fortificazioni, sfruttanti l’eccellenza strategica dell’emergenza rocciosa, separata dal resto dell’isola da una profonda depressione naturale.
Fu in questa sede che il generale bizantino Giorgio Maniace costruì alcune opere fortificate, delle quali nulla ci è dato di sapere, se non fosse per la tradizione che operò il trasferimento del suo nome al più recente castello federiciano. Fu questo il più antico, sebbene non il più arcaico, fra i castelli svevi di Sicilia e fra tutti, dopo quello di Augusta, certamente il più bello ed equilibrato nello studiatissimo rapporto compositivo che ne sposò perfettamente l’esigenza militare con la funzionalità della pianta e degli ambienti, in tutto degni di ospitare la dignità imperiale di Federico.
Preceduto da una serie di opere avanzate, delle quali non ci è giunta traccia, si erge su di un impianto perfettamente quadrato (m 41 x 41) scaturente da un quadrato di base, sostituito dall’impluvium, che ne diviene il costituente semplice, l’atomo concettuale.
Il piano terreno era costituito da un unico ambiente, che se non raggiunge la studiatezza di quello augustano, doveva essere di grande suggestione; l’ambiente era scandito da regolari campate, concluse dalle caratteristiche volte a crociera, poggianti su di una foresta di sedici colonne centrali, più quattro semicolonne ai rispettivi lati e; le quattro colonne d’angolo.
L’effetto derivante da questo ambiente, si è già detto, doveva essere straordinariamente suggestivo, nella fusione sia dell’elemento borgognone (le volte, le campate) sia del riferimento emergente da quello zampillio di colonne che ci sembra una soluzione ancora legata al gusto islamico.
Ricavati entro lo spessore murario delle pareti nord e sud erano due grandi camini, dei quali nulla ci rimane, tranne che l’incasso di uno solo, ancora perfettamente leggibile.
Ai quattro angoli della costruzione quattro torri cilindriche ne risolvono gli spigoli, in un perfetto inserto dall’accuratissima opera muraria. A proposito della finitezza dell’opera muraria non si può non ripetere quanto l’Agnello ha provato, vale a dire che le stesse maestranze già impegnate nell’erezione della basilica del Murgo furono trasferite alle fabbriche del castello siracusano; maestranze sapienti, quindi, educate nei migliori cantieri d’Europa, veri maestri artigiani di tutta la nuova architettura dugentesca del vecchio continente.
Alla sala terrena doveva in origine soprastare un’altra elevazione, della quale però non ci è pervenuta traccia, sia per le distruzioni alle quali il castello andò incontro, sia per il livellamento dei muri di cinta, che avrebbero dovuto mostrarci i segni dell’inserzione delle semicolonne, dei camini e delle volte del secondo piano. Tuttavia forti considerazioni analogiche possono sufficiente- mente confortarci circa l’ipotesi dell’esistenza di una seconda elevazione che è da considerarsi come una caratteristica sempre ripetuta in tutti gli altri castelli svevi (Ursino, del Monte, Prato ecc.).
Nel corpo delle torri erano ricavate delle scalette a chiocciola, conducenti tanto alla seconda elevazione quanto al camminamento di ronda. «All’esterno, la parte più importante [del castello] è costituita dalla fiancata nord-ovest, su cui si apre il superbo portale, appesantito dallo stemma aragonese sovrapposto nel 1614 per iniziativa del castellano Giovanni de Rocca Maldonato».
Ai due lati di questo portale, su due grandi mensole di pietra erano i due famosi arieti di bronzo, d’età ellenistica, probabilmente allora, come osserva l’Agnello, restituiti dal ricchissimo sottosuolo di Siracusa. L’inserzione di questi due elementi denota, come già abbiamo avuto modo di dire in sede di introduzione, un sempre presente gusto «classico» e ci pare un elemento in più per comprovare l’esistenza di un gusto locale di tradizione araba. La nostra breve argomentazione è che in Italia (Prato ed Andria) questo omaggio al gusto classico è realizzato con l’inserzione organica nella costruzione dei doviziosi portali sormontati dal caratteristico timpano classico, e creanti, insieme al sapiente movimento delle masse delle torri, una zona di movimento ascrivente i castelli in discussione a una sensibilità del tutto diversa da quella «siciliana» presente nei castelli di Augusta, Siracusa e Catania, dove i portali non aggettano minimamente dalla linea dei muri, lasciandone inalterata la cristallina e lineare presenza.
Data la presenza anche in Sicilia di quella vena di classicità (portali) che però si risolve (castel Maniace) fuori dalla costruzione, è chiaro che in Sicilia bisogna fare riferimento a una diversa sensibilità, che è quanto dire a una diversa scuola, che presiedette alla intavolazione volumetrica delle costruzioni; e tanto precisa era quella sensibilità che non poteva assorbire organicamente l’inserto classico, estraniandolo. Ora questa diversa cultura, date le uguali matrici dell’arte sveva, non potè essere che di origine araba.
I due splendidi arieti bronzei secondo la tradizione «furono portati da Costantinopoli in Siracusa, dall’ammiraglio Giorgio Maniace e posti ad ornamento della fortezza da lui costruita in quella città». È necessario rilevare che il passo sopra riportato, relativo a uno studio del La Duca sul castello a mare di Palermo, ci pare, quanto meno, improbabile. In primo luogo Maniace venne, poco dopo il 1030, in Sicilia con una spedizione militare, segnante l’ultimo atto degli sforzi bizantini di riconquista della Sicilia. La spedizione, di grandi proporzioni e di ancor più grandi ambizioni, in effetti conquistò grande parte della Sicilia orientale e Siracusa, le cui fortezze furono ristorate (è quindi in questo contesto che va inquadrato il «primo» castello Maniace), si pensò potesse costituire una valida testa di ponte per una ulteriore penetrazione bizantina. Al seguito di Maniace erano duecento mercenari normanni, alcuni dei quali, più tardi con il conte Ruggero, inizieranno per proprio conto la conquista dell’isola. L’impresa di Maniace fu però effimera e la corte di Costantinopoli, sempre guardinga e gelosa dei propri generali vittoriosi, lo richiamò in patria, considerando anche l’impossibilità di dominare il mare in concorrenza con arabi, pisani e genovesi, sì da garantirsi la riconquista dell’isola.
La nostra osservazione è dunque evidente, dati i fatti di cui sopra. Maniace guidava una spedizione militare il cui esito era incerto; è improbabile che, insieme ai soldati, si sia tirato dietro da Costantinopoli due arieti di bronzo, che potessero servire da ornamento a una fortezza che ancora non aveva costruito.
E se costruita, come è probabile, la fortezza avesse proprio voluto ornarla con qualcosa, Siracusa era ancora ricca di reperti classici fra i quali c’era da scegliere e, in ultimo, ci pare assurdo che nel pieno di un’avventura militare i cui esiti mai sembrarono definitivi e duraturi, nemmeno nel suo periodo migliore, si potesse pensare a «ornare» una fortezza quanto, semmai, a difenderla; ed ancora: Maniace fu richiamato a Costantinopoli, non fuggì in seguito a un disastro militare, avrebbe quindi avuto tutto il tempo per tirarsi dietro i due arieti.
Ci pare quindi che la prima parte di questa tradizione sia del tutto eliminabile, mentre sarà utile, sempre seguendo il La Duca, ricostruire le vicende dei magnifici «pezzi» dal 1448 fino ai nostri giorni. Gli arieti «furono nel 1448 regalati da Alfonso il Magnanimo ad Antonio Ventimiglia… e vennero da questi trasportati in Castelbuono e posti ad ornamento della tomba paterna. Dopo la confisca dei beni dei Ventimiglia, i due arieti passarono di proprietà alla corona e furono dapprima collocati nel palazzo Steri e successivamente nel Castello a mare. Qui rimasero fino al 1556, anno in cui i viceré trasferirono la loro residenza nel palazzo reale, dove trasportarono anche queste due opere d’arte. Nel 1735 i due arieti vennero portati nella reggia di Napoli, ma furono ben presto restituiti a Palermo in seguito alle lamentele dei cittadini… durante i moti del 1820 il Palazzo reale venne saccheggiato e gli arieti buttati dalle finestre. Uno di essi andò perduto, mentre l’altro potè essere restaurato ed oggi trovasi custodito nel Museo Nazionale di Palermo».
Una delle parti di maggior rilievo del castello, oltre al magnifico e intatto portale, rimane la grande finestra del lato sud-ovest che per quanto bruttata e sconciata mostra ancora l’eleganza delle sue linee e la purezza della propria impostazione. -

Pasquale Sgandurra
Gli Sgandurra, …I’esilio e la Mastrarua
La Mastrarua, scrisse Vincenzo Consolo, è “…la più luminosa, la più barocca, la più favolosa delle vie di Siracusa”.
Dimessa e aristocratica, semplice ed insieme misteriosa come la gente che un tempo la popolava, la Mastrarua rappresentava l’essenza stessa di Ortigia, una sorta di microscopico universo dentro l’isola. Era animata dal suo variopinto popolo di baroni e pescatori, di professionisti ed artigiani. Era decorata dal suo miscuglio di case modeste e di palazzi aristocratici, di chiese barocche e di cortili spagnoli. Era ravvivata dal suo chiassoso mercato e dal caratteristico slang dei suoi venditori ambulanti. Era profumata dal suo mare schiumoso ed inconfondibile per quell’ inebriante odore di alghe e per quella polvere d’acqua marina, che si sprigionava dallo schiantarsi delle onde contro la sottostante scogliera, avvolgendo tutto, gabbiani impauriti e medievali palazzi, in un’atmosfera fiabesca. Era insomma la Mastrarua, la più siracusana delle vie di Siracusa. Anticamente le strade di molte città del Sud erano più note per il nome delle famiglie che vi abitavano che per quello impostovi dalle autorità. Nel secolo scorso se c’era una famiglia che avrebbe potuto dare il suo nome alla, per altro già popolare, Mastrarua, questa era quella degli Sgandurra: non molti per la verità nella Siracusa dell’Ottocento, ma raccolti quasi completamente in quella strada “luminosa”.
Negli archivi parrocchiali di San Pietro al Carmine intorno al 1880 risultavano annotati ben tré nuclei familiari in meno di venti metri di Mastrarua, gli Sgandurra Scalfaro, gli Sgandurra Sastri e gli Sgandurra Orefice, mentre altri vi erano annotati nelle immediate vicinanze.
Il capostipite di questa famiglia, Santi Scandurra discendente da un leggendario guerriero dell’epopea del Cid, era originario della Spagna ed era giunto a Siracusa nel 1669 …per colpa di un “esilio”. Suo nonno, infatti aveva capeggiato una rivolta di nobili contro il Re a Madrid.
Messe radici a Siracusa, i suoi eredi finirono per “colonizzare” nei secoli la Mastrarua.
In questa antica e fascinosa strada sorge una piccola casa di candido intonaco sul cui portale una lapide ricorda ai frettolosi passanti che fra quelle mura nacque nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, Sgandurra per parte di madre; ma questa stessa casa, ventisei anni prima, aveva visto i natali dello scultore Pasquale Sgandurra: rispettivamente nipote e zio di una stessa famiglia, la cui storia moderna si è dimostrata non meno “prodigiosa” delle sue stesse leggendarie origini.
È da questa casa che ha inizio adesso il nostro racconto.La scuola d’arte di Siracusa
elogiata da Camillo Boito
Pasquale Sgandurra nacque a Siracusa il 18 aprile 1882 al numero 140 della Mastrarua, oggi Via Vittorio Veneto ed allora Via Gelone 154. Sua madre si chiamava Angela Orefice, suo padre, Salvatore. Era il quarto di cinque figli: Antonino (1873) insigne botanico ed avvocato affermatosi a Genova, Giuseppina (1876) rimasta nubile, Lucia (1879) sposata Vittorini, lo stesso Pasquale (1882) ed infine Maria (1886) sposata Imperlini a Benevento.
Il capofamiglia, Don Salvatore, era un barbiere assai popolare allora in città, ed all’occorrenza anche un coraggioso cerusico. Alto, biondo e con gli occhi azzurri come un antico normanno, ispirò uno dei personaggi immortali della narrativa vittoriniana: il “Gran Lombardo”. Un giorno dell’anno 1906 lo scrittore Edmondo De Amicis, in soggiorno a Siracusa, passando per la Mastrarua entrò nel suo negozio, lo conobbe, ne rimase affascinato e scrisse di “non aver mai incontrato nella sua vita un barbiere così colto”. Don Salvatore ebbe un ruolo importante nella formazione dei suoi figli.
Compiuti i primi studi presso il vicino Ginnasio “Gargallo”, Pasquale Sgandurra all’età di quindici anni si iscrisse alla Scuola d’Arte di Siracusa, che frequentò dal 1897 al 1900. La Scuola d’Arte aretusea, rara scuola modello nella Sicilia di quel tempo, suscitò le attenzioni persino di Camillo Boito, che le dedicò nel 1902 un lusinghiero articolo sul periodico “Arte decorativa e industriale”. “Oggetto d’interesse della rivista — scrive a tal proposito Giovanna Finocchiaro Chimirri — erano state generalmente scuole dell’ordine superiore; l’attenzione focalizzata per la prima volta sulla piccola scuola è motivata dal gusto fresco e dalla qualità dimostrati nei lavori espressi dagli studenti siracusani”. Fondata già nel 1883 e diretta dal 1891 da illustri docenti della scuola di Torino, centro propulsivo, allora, del movimento modernista, la Scuola d’Arte di Siracusa in meno di un decennio aveva conquistato posizioni di primo piano nel panorama culturale nazionale, balzando così agli onori della cronaca. Dalle notizie su insegnanti e allievi della Scuola si apprende che lo Sgandurra fu uno degli allievi migliori. Del resto l’ambiente artistico siracusano dell’epoca si mostrava molto prolifico e stimolante. Basti ricordare il pittore Trombadori, oppure, per restare nell’ambito dell’arte plastica, lo scultore siracusano Gregorio Zappala autore della magnifica Fontana delle Sirene di Piazza Navona in Roma, ovvero l’altro grande scultore siracusano Luciano Campisi celebre negli Stati Uniti per i suoi capolavori in memoria di Dante e Verdi eretti a Boston.
Una volta diplomatesi ed ottenuta l’abilitazione all’insegnamento, Pasquale Sgandurra cominciò a lavorare presso la stessa Scuola che lo vide prima studente. Dal 1900 fu professore di plastica presso la Scuola d’Arte di Siracusa e saltuariamente insegnante supplente di disegno presso la Scuola Tecnica “Archimede”. Cominciò allora a specializzarsi nell’arte sacra e a ritagliare nella creta immagini di argomento religioso.
“Per rappresentare Dio — scrisse un giorno lo Sgandurra — fonte perenne di bontà, di bellezza, l’artista dovrà necessariamente servirsi del bello formale”. In quegli anni Pasquale Sgandurra aveva a disposizione un’aula della Scuola d’Arte che utilizzava come laboratorio e come cenacolo d’arte e di cultura, ritrovo di alcuni giovani artisti siracusani, fra i quali i pittori Adorno e Majorca e l’incisore Alfonso Ricca, figlio del direttore della Scuola d’Arte, un rinomato scultore napoletano trapiantatesi a Siracusa. A questa affiatata comitiva si aggregò nel 1903 un giovane poeta, Sebastiano Vittorini, futuro cognato dello Sgandurra. Fra i due nacque una profonda amicizia e il Vittorini cominciò a frequentare la casa degli Sgandurra alla Mastrarua, dove conobbe Lucia, poi divenuta sua moglie. Pasquale Sgandurra e Sebastiano Vittorini erano accomunati dalle stesse aspirazioni, dagli stessi interessi culturali.
Uomo schivo e di poche parole, di carattere volitivo, anticonformista, dotato di un’eleganza vagamente dannunziana e dongiovannesca, libero nel vestire come nel comportamento secondo certi modelli d’oltralpe, Pasquale Sgandurra, da vero esteta della vita, esercitava un autentico fascino sul giovane amico Sebastiano, il ‘quale poi in alcuni suoi scritti avrebbe ricordato quei tempi ed in particolare la loro comune frequentazione della “Leone di Caprera”, una società sportiva di Siracusa dove si faceva scherma, lotta greco-romana ed esercizi agli anelli e alle sbarre.
Dagli scritti di Sebastiano Vittorini sappiamo che in quegli anni Pasquale Sgandurra soleva recarsi spesso sulla collinetta di Teracati per ritrarre la campagna siracusana dal vero, “en plein air”, come un epigono dell’impressionismo, altre volte invece era solito recarsi con gli amici alla Marina per catturare i colori di quei magici tramonti siracusani che ispirarono poeti e pittori e che fecero esclamare al Carducci la celebre frase “…bello come un tramonto di Siracusa”
“La passeggiata alla Marina — scrive Jole Vittorini — era quanto di meglio offrisse Siracusa all’inizio del secolo. Era il nostro salotto elegante, dove si ascoltava una dolce orchestrina viennese o la banda cittadina; dove i giovani innamorati si scambiavano sguardi intensi di desiderio e fiori di bianco e profumatissimo gelsomino. E mentre i più avventurosi sognavano d’imbarcarsi sugli yachts allineati lungo la marina, i più pigri preferivano il pettegolezzo di provincia, allungati sulle poltroncine dei caffèDall’Accademia di Firenze
ai capolavori canadesi di Montreal
Nel 1904, intanto, la commissione di una tela per il Salone di Palazzo Vermexio (oggi purtroppo andata perduta), diede l’occasione allo Sgandurra di accumulare i primi soldi necessari per trasferirsi a Firenze e poter studiare all’Accademia delle Belle Arti. Vi si recò col pittore Adorno ed altri due amici siracusani e frequentò l’accademia fiorentina dal 1904 al 1908, sostenendo economicamente i suoi studi grazie ai lavori affidatigli in Toscana. Ritornato a Siracusa, nel 1908 riprese ad insegnare presso la Scuola d’Arte e nel 1914, in collaborazione con Duilio Cambellotti realizzò il Bozzetto delle scene per il primo ciclo delle Rappresentazioni Classiche al teatro greco. Ma nello stesso 1914, all’età di trentadue anni, lasciò per sempre Siracusa, trapiantandosi stabilmente a Firenze, dove mise su un fiorentissimo laboratorio d’arte al numero 177 dì Via Faentina, nella periferia nord della città ai piedi della collina di Fiesole.
Dopo la parentesi della prima guerra mondiale, insieme all’attività di scultore Pasquale Sgandurra sviluppò pure quella di docente presso il Liceo Artistico di Firenze e poi presso la prestigiosa Accademia delle Belle Arti. Divenne anche componente della commissione edilizia della città, assumendo un ruolo di primo piano nella vita culturale ed artistica di Firenze.
La notorietà delle sue opere cominciò a valicare i confini nazionali. Ben presto ricevette molte commissioni da diverse città d’Europa e d’oltre Oceano, ed in particolare dal Canada dove il suo nome divenne assai popolare.
Saltuariamente, tuttavia, lo Sgandurra fece brevi ritorni a Siracusa. Nel 1925 la morte del padre Salvatore fu l’occasione di un lungo soggiorno siciliano. L’espressione sofferta del viso del vecchio padre lo turbò non poco e gli ispirò il volto del bellissimo Crocifisso che realizzò da lì a poco per la Cattedrale di Montreal, considerato da molti come uno dei suoi maggiori capolavori. Una copia di minori dimensioni di questo Crocifisso esiste oggi nella Chiesa del Pantheon di Siracusa. Durante questo suo primo soggiorno aretuseo realizzò diverse opere per soddisfare la committenza locale. Notevoli i busti dei genitori e del cognato Sebastiano Vittorini, nonché quello del popolare personaggio di “Sarò m’abbrucia”, oggi custoditi presso collezioni private di Siracusa. Un suo monumento a Garibaldi presso la piazza centrale di Avola fu poi distrutto dalle autorità fasciste.
Ritornato a Firenze, realizzò nel frattempo le statue dei “Quattro Evangelisti” sempre per la Cattedrale di Montreal. Erano gli anni in cui Io Sgandurra scolpì il celebre gruppo della “Pietà” per la “foscoliana” Chiesa di Santa Croce in Firenze, una cui copia fu richiesta anche per la Cattedrale di Cassino. Pregevoli pure l’ “Estasi di Santa Teresa”, la “Vergine col Bambino”, il “Sacro Cuore” e, soprattutto, il maestoso “Cristo Re” per la Chiesa omonima di Torino, che fu esposto alla Fiera internazionale di Barcellona in Spagna nel 1929.
L’anno successivo Pasquale Sgandurra, ormai affermato, ospitò a Firenze suo nipote Elio, allora ventiduenne e desideroso di inserirsi nella vita culturale fiorentina, fulcro in quel tempo di tutta la vita artistica e letteraria del paese. Il giovane Vittorini fu introdotto dallo zio negli ambienti culturali di “Solaria”, divenne grande amico di Montale e si portò dietro il cognato Salvatore Quasimodo. Ecco come la moglie di Vittorini, Rosa Quasimodo, ricorda l’arrivo a Firenze col marito e col figlio Giusto ed il loro soggiorno nello studio di Via Faentina:
..A Firenze ci restammo. Era il 1930. Dormimmo per un po’ nello studio dello zio di Elìo, Pasquale Sgandurra, scultore. Era pieno di statue. Dalle vetrate, la notte, entrava il chiarore della luna, e le statue così bianche ci facevano paura. Di giorno il piccolo Giusto offriva caramelle per ingraziarsi le statue, e le lasciava sui loro basamenti”.
Nel febbraio del 1934 Pasquale Sgandurra tornò nuovamente a Siracusa per realizzare l’opera “Luce e Tenebre”, due statue di donna raffiguranti l’una la luce della ragione e l’altra la pazzia. Le sculture gli erano state richieste dall’amministrazione provinciale per adornare l’ingresso dell’Ospedale Psichiatrico di Siracusa. Di quell’epoca è la scultura dell’Atleta”, una delle poche opere non riguardanti soggetti sacri.
Nel 1936 una nuova commissione gli diede l’occasione di tornare ancora una volta a Siracusa, per realizzare il monumento del Vescovo Carabelli oggi collocato nella Cappella del Crocifisso della Cattedrale aretusea e definito dai critici come il suo autentico capolavoro. La circostanza fu buona per fermarsi a lungo in Sicilia, vista la vastissima richiesta della committenza locale. Frutto di quest’ultimo lungo soggiorno furono molte opere per le cappelle di diverse famiglie siracusane presso il cimitero monumentale della città, tra le quali di particolare rilievo quelle delle famiglie Gargallo, Agnello, Agati, Giaracà e Vittorini.
Da quell’anno lo Sgandurra non sarebbe più tornato in Sicilia. Il 27 maggio del 1950, ormai sessantottenne, sposò la sua compagna di sempre Teda Ventura, una bella signora fiorentina, conosciuta già negli anni Trenta. Pasquale Sgandurra morì a Firenze il 26 febbraio del 1956.
Fino all’inizio degli anni Settanta, presso l’Istituto d’Arte di Siracusa era allestita una mostra permanente delle sue opere e davanti all’Ospedale Psichiatrico si potevano ammirare ancora le due statue della “Luce” e delle “Tenebre”. Ma oggi, purtroppo, l’artista siracusano non ha evitato l’ingiusto destino di oblio che la città ha riservato a tanti suoi figli meritevoli di maggiori attenzioni. E così, il “Crocifisso” del Pantheon ed il “Carabelli” della Cattedrale sono rimasti gli unici muti ma tenaci testimoni del “passaggio” di questo valoroso scultore dalla sua amata ma “smemorata” città.Il giudizio del nipote Elio Vittorini nel 1929:
“.. le perdite dell’ ingratitudine”
Il migliore studio sull’opera dello Sgandurra è senz’altro il saggio del Professor Giuseppe Agnello, “La scultura religiosa di Pasquale Sgandurra”, pubblicato nel 1934 sull’ “IIIustrazione Vaticana”, e al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.
È assai interessante, tuttavia, rileggere un illuminato e profetico articolo dell’allora giovanissimo Elio Vittorini, che nel 1929 da Siracusa scrisse una breve recensione su “L’Italia Letteraria”. Il notevole interesse suscitato dal brano vittoriniano deriva dal fatto che già allora l’autore rimproverava ai propri concittadini l’indifferenza e la grave mancanza di riconoscenza verso un artista che aveva da poco donato alla sua città il “Crocifisso” copia del bronzo di Montreal, ed al contempo la consapevolezza di dover subire lo stesso de- stino d’oblio nel momento in cui egli stesso si sarebbe dovuto allontanare dalla sua Siracusa per affermarsi come scrittore al Nord.
“Penso — scriveva Vittorini — che un cauto omaggio, da qui, allo Sgandurra è dovuto. Nella sua partenza di avanti guerra da questa testa di ponte a una piazza fiorentina, partenza allora favolosa e ricca di promesse, c’è l’esordio, il principio di tutte le partenze che faremo noi stessi, poco a poco, verso l’alta Italia. E la pronta dimenticanza in cui è stato soppresso il suo nome quaggiù, dopo le prime glorie cittadine, ci può anche dare il carattere della fatalità di questa provincia dove anche noi scompariremo, nel ricordo dei nostri amici, dei nostri circoli, delle nostre affettuose brigate…”.
In queste straordinarie parole c’è tutta la voglia di affermazione di un giovane e promettente scrittore siciliano ancora ventunenne e nello stesso tempo la coscienza quasi profetica di essere destinato a grandi cose e nel contempo alla dimenticanza tra i suoi stessi concittadini. Elio Vittorini, quindi, si sofferma sulla rapida carriera dello zio: “… i primi sforzi, l’arrivo a Firenze, l’Accademia, la guerra, il primo premio, fino ad arrivare sul piano di uno stadio più visibile ..”.
E finalmente si occupa delle opere più recenti dello scultore: “… Ma la sincerità narrativa dello Sgandurra data invero da recente. E ben si può prendere a foco il panorama delle sue opere puntando lo sguardo su quel crocefisso ch’egli ha donato or è poco alla città natale, e dal quale si può giurare si sia prodotto l’inatteso sviluppo dei quattro evangelisti, della Santa Teresa, della Pietà, della Vergine, e finalmente, adesso, del Cristo Re.
Con quest’ultimo passiamo d’un tratto, è bene dirlo, a un’intesa artistica più reale. Si sente che lo Sgandurra va liberandosi della mortificante cultura di avanti e dopo guerra. Nei suoi princìpi oggi si legge con libertà. Egli che è stato pur sempre calmo anche nel gravare la mano sull’abbigliamento un po’ secentesco, un po’ di maniera, dei suoi santi, diventa adesso quasi sorridente, padrone assoluto di una affettuosa materia. La sua arte si fa nobile, trattata famigliarmente si fa umana, e, premio ambito, atteso lunghi anni, il suo Cristo si muove per primo, ad accettare la devozione dell’artefice”.
Quindi il giovane Vittorini accenna ad un suo recente soggiorno fiorentino presso il laboratorio dello zio per ammirare la maestosa statua del Cristo Re:
“Ora che siamo passati da Firenze avremmo voluto vederlo. Invece la nostra visita allo studio, quello studio fresco e profondo dove la grande chiarezza del lucernario fa vivere le statue come in un acquario, si è dovuta limitare a una esperta ricognizione fotografica tra le cento prese di scorcio, di fronte, di tergo e di particolari che lo Sgandurra aveva accuratamente rilevate prima di mandare la statua all’attuale Fiera di Barcellona. E al ritorno di laggiù nemmeno sarà così facile ritrovarla come speravamo nel rimandare il nostro desiderio a una prossima visita più fortunata. Di laggiù il lavoro dello Sgandurra è atteso a Torino, nella nuova chiesa dedicata a Cristo Rè…”.
E infine conclude amaramente:
“…e semmai quel buon siracusano che rimpianga l’irreparabile vuoto di qualche piedistallo cittadino potrà, con un devoto pellegrinaggio, riparare alle perdite dell’ingratitudine”.
L’anno successivo Elio Vittorini ventiduenne avrebbe lasciato per sempre Siracusa e avrebbe cominciato da Firenze la sua straordinaria carriera letteraria, così come “profeticamente” aveva annunciato in questo eccezionale articolo. -

ABATE ALESSANDRO
Alessandro Abate è nato nel 1867 a Catania, dove è morto nel 1953 all’età di 86 anni .
Scrive S. Nicolosi : ” Era un ragazzo di scarsi mezzi,amava i colori e le tele,trovò due protettori che Gli spianarono un poco la via : il pittore Antonino Gandolfo,che gli insegnò i primi rudimenti della pittura,e l’incisore Francesco Di Bartolo,che……..nel 1893 gli fece assegnare un sussidio ; e così egli potè studiare in una relativa tranquillità economica.A 18 anni opera prima,Dolore e Miseria,presentata all’Esposizione Nazionale di Roma.
Tre anni dopo vinse il concorso del Museo Artistico industriale di Roma …………….Nel 1902 espose alla Quadriennale di Torino ,Eppur si muove,……..a Catania dipinse nelle Chiese di Sant’Euplio e dei Bianchi e decorò numerosi palazzi privati nel ’29-’31 ; a Tripoli espose alla Fiera e dipinse il gran telone del Teatro reale ; nel 1935 , a Tunisi , fece il ritratto al bey….La sua opera fu doviziosa . Gesualdo Manzella Frontini scrisse : < Acquarellista, affreschista, decoratore, paesista e ritrattista , ha trattato il quadro di genere come il grande quadro sociale,la composizione allegorica o storico-allegorica,il soggetto religioso e la decorazione a grandi stili di palazzi e chiese…..l’unico superstite di una dignitosa tradizione pittorica(Rapisardi, Reina, Sciuti,Gandolfo ) > . Le sue tele ed i suoi affreschi erano coloratissimi e rimasero intonati…allo stile romantico che egli prediligeva : decorazioni di tipo floreale,figure languide alla D.G. Rossetti,ondeggiare di nastri e mantelli al coup de fouet . Fra il turbinare delle tendenze pittoriche più rivoluzionarie…..,passò incontaminato,……sordo ai richiami della moda ……coltivandosi fino al giorno della morte,quando erano diventati candidi , i baffi ed il pizzo alla moschettiera,che s’era cresciuti nella prima giovinezza ” .
Riporta G. Frazzetto : ” svolge un’intensa attività come decoratore; ed è in questa veste fra i protagonisti dell’esposizione(CT,1907) ” .
Da ricordare l’iperrealismo floreale del Giardino d’Inverno nel Palazzo Zappalà – Asmundo in Via Etnea a Catania . -

Olivio Sozzi
l pittore Olivio Sozzi, nato a Catania nel 1690, è morto nel 1765 a Spaccaforno(RG), all’età di 75 anni .
Impara l’arte del disegno a Palermo,dove sposa Caterina Cappello,una donna ricca,grazie alla cui dote può completare la sua preparazione pittorica .
Dal 1729 inizia un soggiorno romano presso l’antica bottega del maestro Sebastiano Conca(1680-1764), a sua volta allievo del Solimena (1657-1747) .Risiede a Roma per parecchi anni,durante i quali assorbe la lezione del classicismo romano,ma,soprattutto si ispira alla luminosa lezione di Corrado Giaquinto(1703-1765) con il quale entra in rapporti di familiare e cordiale amicizia . Dopo Roma,raggiunge Palermo,dove nasce il suo primogenito,che farà poi, come l’omonimo nipote, Olivio(1771-1833), lo stesso mestiere del padre .
Nella seconda metà del Settecento in poi, fino alla morte, decide di tornare in Sicilia per intraprendere un’attività frenetica per cui Luigi Scuderi, noto biografo etneo ,Lo definisce “esimio dipintore catanese ” .
Per S. Nicolosi, ” le sue barocche composizioni erano,come quelle del contemporaneo acese,Paolo Vasta, grandiose e di drammatico contrasto luminoso ; predilegeva gli scorci arditi,come era richiesto d’altronde dagli edifici che le sue pitture adornavano : le Chiese…..Era un pittore alla moda,in quel secolo felice per le arti,tra i preferiti quando si doveva affrescare una Chiesa o adornarla con pale d’altare ” .Sue opere trovansi a Catania presso :
-Chiesa di S. Chiara- Via Garibaldi (un quadro con l’Immacolata).
-Chiesa di S. Francesco d’Assisi-Piazza omonima (affresco Virtù Cardinali nei pennacchi della finta cupola).
-Chiesa di S. Giuliano di Via Crociferi(tela con Madonna delle Grazie ed i Santi Giuseppe e Benedetto).
-Chiesa della SS. Trinità-Via Quartarone(pala di S. Benedetto e la SS. Trinità) .
-Chiesa della Collegiata-Via Etnea(Gloria di S. Apollonia,primo altare a dx) .
-Chiesa di S. Domenico-Piazza omonima (S. Vincenzo che resuscita un bambino, primo altare a dx) .
-Chiesa di S. Francesco Borgia o dei Gesuiti-Via Crociferi : Cupola .
a Militello(CT) presso : Chiesa di S. Maria della Stella.
a Naso(ME) presso : -Chiesa Madre.
a Tusa(ME) presso : -Chiesa di S. Pietro.
a Gioiosa(ME) presso : -Chiesa Madre.
a Patti(ME) presso : -la Cattedrale .
ad Avola(SR) presso : -Chiesa Madre di S. Nicolò .
a Melilli(SR) presso : -Chiesa di San Sebastiano .
ad Ispica(RG) presso Chiesa di S.Maria Maggiore .
a Paceco(TP) presso : -Chiesa Madre .
a Palermo presso : Chiesa della Martorana; Chiesa del Monastero di Valverde e Chiesa di S Agostino .
a Trapani presso : Museo S. Giuliano,S. Gregorio,S. Carlo .
a Mezzoiuso(PA) presso: Chiesa di S. Maria delle Grazie .
a Canicattì (AG) presso : Badia dei Ss. Filippo e Giacomo.
a Comiso (RG) .
Un giorno della Settimana Santa del 1765, Olivio Sozzi, mentre, insieme all’allievo e genero,Vito D’Anna, va completando a tempera il ciclo di affreschi compiuti per la Cappella Grande della Chiesa di S. Maria Maggiore a Spaccaforno, oggi Ispica, precipita da un ponte-impacaltura, muore ed ivi viene sepolto .SOZZI
pittore del Settecento siciliano
Il giovin Olivio svolge il suo primo apprendistato a Palermo presso Filippo Tancredi…………e si trasferisce a Catania nel 1750 .
E’ presente nel Siracusano solo a partire dal 1752 a Melilli (Chiesa di S. Sebastiano) .
Nel 1763 , per gli affreschi della Chiesa di S. Maria Maggiore, è ad Ispica (RG), dove muore nel 1765 e viene sepolto nell’angolo dx della Cappella dell’Assunta, nell’omonima stessa Chiesa di S. Maria Maggiore, da lui affrescata , fino all’ultimo, insieme al genero, Vito D’Anna ( Palermo, 1718-1769) .
L’Arciconfraternita, nel 1990 (Terzo centenario della nascita ) e nel 1998 gli ha tributato i dovuti onori .
Suo degno rivale in pittura, in Sicilia, fu l’acese Paolo Vasta (Acireale,1697-1760).
Una sua tela settecentesca è visibile presso la chiesa di S. Filippo ad Agira (EN) . -
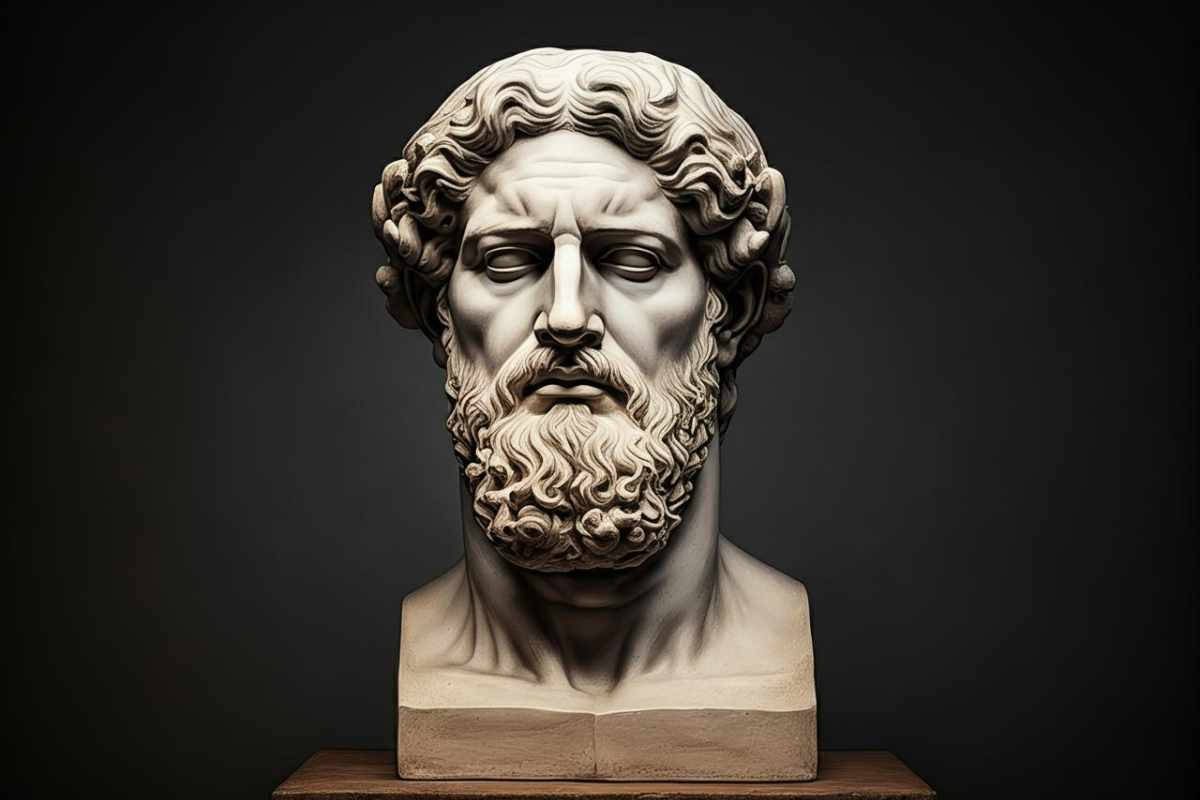
Giordano Salvo
Salvo Giordano,nato nel 1907 a Catania,ha insegnato Figura modellata al Liceo Artistico (Catania, ’48 -’76).
Il padre è importatore di marmi e pietre,per cui apprende giovanissimo a maneggiare lo scalpello; a tredici anni riproduce nel marmo, dal Duprè, un busto del filosofo V.Tedeschi, che ora trovasi al Giardino Bellini,nel Viale degli Uomini Illustri ; meno che ventenne si trasferisce a Milano e per qualche mese è aiutante di Adolfo Wildt . Nel ’27 vince il concorso per una statua raffigurante V. Bellini nel Foyer del Teatro Massimo, collocata però soltanto nel 1951,dopo 20 anni ;nel 1931 è tra i prescelti per il concorso di secondo grado(mai espletato) per il monumento al Cardinale Dusmet , nel 1942 partecipa alla Quadriennale(Roma).Personaggio influente nell’ambiente artistico catanese,anche per le sue doti di organizzatore,crea ,negli anni Quaranta-Cinquanta,la Galleria S. Demetrio(nell’omonimo Palazzo ai Quattro Canti) per far esporre gli artisti siciliani emergenti .
Scrive L. Biondo : ” collaborò con G. Libertini,tra il 1931 ed il 1935,alla sistemazione del Museo Civico del Castello Ursino . Nel 1942 ebbe un incidente con la polizia fascista…..i militi stavano per arrestarlo …e fino all’arrivo degli alleati in Sicilia lavorò solo con la terracotta . Nel Viale degli uomini illustri del Giardino Bellini scolpì i busti di Federico De Roberto,Giovanni Grasso senior ed Alfredo Sangiorgi…..; per la biblioteca universitaria, il busto di Giovanni Verga . Alla fine degli anni Settanta rifece il busto di Giovanni Parini, collocato nella Villetta omonima.………..Suo è il grande bronzo (Deposizione,1974) nella Chiesa di Santa Maria di Gesù…..Ha eseguito scenografie per numerosi Teatri italiani (fra cui il Bellini di Catania) ” .
Per P. Rizzo , “presenta un gruppo di terracotte (figure, animali, frammenti)….che ci richiamano le nostre antiche sculture greche” .
Per C. Belli, ” Non so quale purezza di sagome,quale gentile fissità poetica rendeva i bozzetti di Giordano simili ad un affresco”.
Per Frazzetto,”si fa notare per la raffinatezza sensuale e l’elegante intellettualismo grecizzante delle opere di piccolo formato……. ” . -

SPINOCCIA
Il pittore-incisore,Pippo Spinoccia, artista di lungo corso,”tra i più impegnati, nel panorama culturale italiano”,è nato a Siracusa il 7/Genn./1928,ma da quasi 40 anni vive e lavora a Milano e trascorre il periodo estivo nella riviera ligure. Dopo aver intrapreso gli studi classici li ha interrotti per dedicarsi allo studio della musica e del pianoforte;in seguito,alunno di Ferri e Monica,amico di A.Romano e V.Lucca, ha frequentato la Scuola d’Arte di Siracusa(’45-’49), il Liceo Artistico di Palermo(’49-’51),dove si è iscritto alla AA.BB.(’51-’55), conseguendo il Diploma,allievo di Gino Morici e divenendone poi l’assistente. Ha compiuto la sua formazione artistica a Siracusa, Palermo, Roma, Salzburg, Monaco, dove ha soggiornato per lunghi periodi. Dal ’56 al ’65 è stato scenografo presso i Piccoli Teatri Stabili di Palermo , Catania 9 Bolzano ; negli anni palermitani,insieme a B.Caruso,A.Pecoraino,G.Baragli,ha partecipato al dibattito culturale ed artistico della città.
Dagli anni ’61-’62,avendo frequentato il corso di litografia diretto da Soucek(Austria),si dedica all’arte grafica.
Dal ’56 al ’64 è stato assistente di decorazione all’AA.BB. di Palermo ; poi ha insegnato Disegno alla Scuola Superiore degli Artefici di Brera-Milano.
Amico di Sciasciaa e Bufalino, pittore a rebours, è noto per l’impulso minimalista delle sue opere che ricercano le radici della forma e delle immagini ; prima Personale alla Galleria “La Fontanina (Sr,’55,’63), la più recente alla Gallerìa Satura (Genova,’01).
Per Falabrino ,”spiega la condizione umana, indagata senza le mitizzazioni della Sicilia popolare, o le consuete nostalgie o raffronti con le città industrializzate…”, ed invece a Vincitorio,” risulta chiaro come questo pittore ha saputo pervenircela pure con cadute e gradini scalati passo passo,ad una maturazione di linguaggio che rende le sue altrettanti urti alla coscienza di qualsiasi osservatore “. Rossana Bossaglia parla di “teatralità che tocca i limiti del surreale o stride nelle espressionistìche deformazioni… “.
Riportiamo.in parte,quanto il critico floridiano, Vittorio Fagone, sulla rivista Kalòs/99, ha scritto : “Le opere di Spinoccia, tutte date in una sorta di esaltazione del segno grafico,in una figuralità primaria,allusa, e, alla lettera,allucinata,dichiaravano più di una ragione,poetìca e strutturale, che non ne rendeva possibile l’assimilazione alla proposta di una <pittura di intenzione. Spinoccia ha lavorato, sempre da pittore,per le scenografie di diversi teatri italiani e a specchio,non ha mai avuto difficoltà ad animare il suo quadro come scena ; praticabile – in tutti i sensi -oltre che illusionisticamente conclusa. L’artista abita costantemente questa scena immaginata ed ama provocare lo spettatore a condividerne la spazìalità complessa in un gioco esplorativo e ridifinitorio.
La sua pittura, per molti versi, ama proporsi piuttosto come metapittura: un luogo articolato di stratificati depositi e di reversibili distanze. Le ascendenze, le affinità, dell’opera di Spinoccia son disperse in aree, culturali e linguistiche, diverse. La più certa,che corrisponde a una scelta precoce, inconsueta in un artista di estrazione mediterranea. rìnvia a Otto Dix, il pittore pungente della città turbolenta, delle vite ,armato di una ironia umanizzata, solitària e terribile” .
Un sì vasto palmares di mostre e recensioni d’arte, per “Capire il Labirinto” di sue installazioni e disegni, è sufficiente per inserire il nostro graffiante ed satirico settantaquattrenne Pippo, pittore alla Baj , ne u!! Quartiere” della instituenda Fondazione d’arte a Siracusa? Opere di quesfartista,affermato specie nel mondo germanico, sono reperibili presso: Avida Dollars, Ciovasso, Arte Studio Linea, Spaziostudio, Trabucco Cecconi (Milano), Galerie Art Actuell (Monaco,Dusserdolf,Francoforte), De Falco Editore (Novara), Galleria Satura(Genova), Di Vita Carrer Mail Art CoUection.
-

CARTA
Sebastiano Carta , artista ad ampio raggio , definito da Gerbino ” biologicamente ed equivalentemente commisto di corporietà e spiritualità “, è nato il 4 Marzo 1913 a Priolo ( Sr). Trasferitosi a Roma, si lega molto presto al Gruppo Futurista Romano esprimendo, sin da giovane, il proprio brioso disagio esistenziale attraverso la poesia e la pittura, e producendo futuriste tavole parolibere (‘ 33), ed astrazioni tonali; d… vita nel 1936 al Manifesto della Poesia Murale, espone da Bragaglia (‘ 36 ) e neI 1938 si sposta da Roma a Pavia A partire dal 1940 viaggia, dipinge e partecipa a delle manifestazioni artistiche; costituisce, a Roma, neI 1944 la Casa Rossa , gruppo di cultura antiborghese, con Stradone, Dorazio , Zavattini , Guttuso.
Aderisce poi al Gruppo di pittura astratta comasca di Valori Primordiali, dopo essersi unito al gruppo Primordiali Futuristi Sant’ Elia a cui aderivano Celiberti, Matacotta e Mannetti. Molte le sue pubblicazioni poetiche e le sue cartelle d’ arte, come interessante Š la sua attività legata per alcuni aspetti alla poesia visiva: Campo mobile (1936 )’, Nostro passo quotidiano e Poesie (1940) , Canto largo (1955), Medioevo ( 1956).
Il famoso critico d’arte, Enrico Crispolti, nel 1964 , annotava le sue capacità di ampliare possibilità espressive diverse e che i suoi fogli di pittura erano uno stesso modo di divagazione inventiva , assai fresca nella sua libertà di svolgimento, che ora sembra fissarsi verso un arabesco formale , ora accenna quasi a uno spunto narrativo. Lo scrittore Zavattini scriveva: “Carta quando stende davanti ai suoi amici i grandi fogli di pittura, si ricomincia ad amarlo e a stimano. Ci aggiriamo attorno a questi fogli come alle figure che i pittori ambulanti fanno sui marciapiedi. Non ci sono per• figure, c’ è solo il colore che Lo spazio Š infatti materia del suo mondo Sapere cogliere in tanta visionaria instabilità dei momenti fermi , equivale a quando all’ infinito tempo si d… la misura umana delle stagioni Gerbino elogia “la sua enclave creativa fuori dalle urgenze e mode di mercato : cromatismi e circolari tensioni del segno , gli ocra mescolati, con la sapienza di quella felice instabilità zavattiniana, agli azzurri tenui, ai bianchi improvvisi , ai rossi ed ai commisti toni delle patine pastello. Tra queste visioni dell’ intimo , che si potrebbero definire geografie spirituali, Carta annotava i suoi Quaderni umani, giochi, calembour del segno e della parola, in una mescolanza interattiva tra versi , grafie istintive, colore e materia del sogno. Una visibilità concepita in ogni momento della sua quotidiana inventiva: schizzi , vivacità prospettiche della penna e del verso di stampo futurista che egli continuò a rielaborare anche alla fine degli anni Settanta
Ed inoltre, continua Gerbino : “Corpulento , sguardo incisivo, lineamenti volitivi e piacevoli, barba fluente, brizzolata verso I’arco ultimo della sua vita, si muoveva con la disinvoltura propria di chi vive e vede la costante figura di un’ idea fissa, mossa dal desiderio tenace di una fanciullesca verità Era convinto che un’ artista dovesse essere tale anche dal punto di vista fisiognomico, profondamente coinvolto sia nella tempra sia in quella esteriore. Ma era anche plateale performer, si direbbe oggi, (non a caso sono frequenti le sue apparizioni in veste di santo nei set cinematografici); platealità più che irruente , fluente, fatta di una buona e densa ondata di caldi ed onesti sentimenti ” . Amico fraterno dell’artista Lino Tardia, Carta è morto, inaspettatamente , a Roma nel 1973 , all’ età di 60 anni. In ricorrenza del prossimo novantesimo anno di nascita , gli addetti culturali del Comune di Priolo e della Provincia Regionale di Siracusa sono invitati a rendere omaggio a questo vero artista, siracusano doc, romano adottivo!Diario Doc – Siracusa 2001
CARTA
smantellatore di speranze
Pittore futurista ed astrattista , squattrinato e povero in canna , amante del buon vino , amico di E. Pagano , titolare della Galleria
Il Nibbio di Bagheria ( PA ) .
Per D’ Alessandro , è ” immaginifico e sorprendente inventore di una realtà estemporanea , tutta da costruire sul filo dell’ assorta malinconia ; da consumare sull’ oblio delle proprie manifeste contraddizioni ” .
Mostre principali : Il Triangolo (Palermo , ‘ 71 ) , Il Nibbio
( Bagheria , ‘ 71 ) , Retrospettiva alla Galleria Il Poliedro
( Bagheria , ‘ 79 ) .
” Noi siamo perversi o illusi incantati o deserti . Sono solo , dipingere è un togliersi di mezzo ” ( S. Carta ) .
( Ricerca tratta in parte da E. Pagano , N. D’ Alessandro : S. Carta ,
catalogo per la mostra Retrospettiva al Poliedro , Bagheria , 1979 ) .CARTA
pittore astratto-futurista
La maggiore studiosa dell’attività del pittore astratto-futurista, Sebastiano Carta , è la romana Claudia Salaris .
Da ” La Sicilia” , a firma Daniela Frisone , riportiamo in parte :
” ….. Il padre era guardia di pubblica sicurezza : Carta fu un giovane di talento .Agli esordi grintoso e funambolico, in lotta con i tempi e con la sua Sicilia , da cui evase per un ” sogno romano ” .
Giovanissimo, neppure ventenne, conobbe F.T. Marinetti , che con grande entusiasmo lesse il suo manoscritto < Sistemazione fisica > .
Essendo pittore, oltre che poeta , comprese profondamente il concetto di simultaneità di tempo e spazio , di compenetrazione tra immagine e sensazione .
Le tappe in ambito pittorico vanno dall’ astrattismo , con particolare riferimento a Carlo Belli , alle avanguardie scapigliate nelle esposizioni del ‘ 36 e ‘ 38 ( Bragaglia ), attraverso il naturale inserimento negli anni ‘ 40 nel Gruppo comasco futurista dei Valori Primordiali fino a giungere alla fusione fantastica di racconto e arabesco negi anni ‘ 60 . Il passato , o meglio l’ immagine del passato,si faceva spazio nella coscienza di un uomo , ormai guarito dalle frenesie del futurismo , ma sempre più ammaliato dal forte richiamo dell’ infanzia ……….; allora comprendiamo come Carta avesse vissuto profondamente la volontà della partenza , l’ esperienza futurista , il presagio ermetico , per ritornare là dove tutto era cominciato……. ( D. Frisone ) ” .Diario Doc – 2001
CARTA
l’astrattista
Mostre Personali degne di nota : Galleria Bragaglia ( Roma, ‘ 38 ), L’Obelisco( Roma,’47 ) , Grigio ( Roma, ‘ 61 ) , Numero ( Roma, ‘ 62 ),
Cerchio ( Roma, ‘ 64 ), Galleria Haus der Kunst ( Monaco, ‘ 61 ),
Galleria La Vela ( Bergamo, ‘ 64 ), Galleria 2000( Bologna, ‘ 65 ) ,
Esposizione Quadriennale ( Roma, ‘ 65 ) .
E con Sebastiano Carta sono ben 13 gli artisti aretusei presenti alla Quadriennale Romana .Le carte di S. CARTA
Elisabetta Carta, figlia dell’Artista
Le sue opere sono abbozzi,scritture visive, manipolazioni della grafia comune resa quasi irrriconoscibile dall’aggiunta o dall’asportazione di alcuni elementi . Sono i pensieri che si tramutano in espressioni visibili sconfinando in realtà astratte e formali, divenendo volti deformi, macchie di colore, giochi di riempimento cromatico, percorsi smontabili e traiettorie di inchiostro .
Mostra Retrospettiva : Galleria 71 ( Palermo, 2002 ).
” I miei temi cercano di narrare, o meglio di evocare,immagini di una realtà dove i nostri sentimenti siano trattati come minerali,dove le molecole possano persino dimostrarsi ciniche e spietate ” .( S. Carta).CARTA, pittore futurista
Caratteristico personaggio del movimento Futurista degli anni Trenta e costante punto di riferimento per gli artisti siciliani emigrati fu Sebastiano Carta( 1913-1973),grande polemista,poliedrico pittore-poeta.
Dopo una breve esperienza a Paris, si trasferisce a Roma( ’29 ), si avvicina al Gruppo Futurista Romano,espone da Bragaglia fuori commercio ( Roma, ’36, ’38 ) . Amico dello scultore Schilirò, nel 1940 si stabilisce a Pavia, nel ’44 torna a Roma e con Stradone,Dorazio,
Zavattini e Guttuso fonda la Casa Rossa .
…..L. Lambertini ha curato una splendida monografia d’arte per la Galleria Battaggia di Roma ed un suo libro di poesia visiva degno di nota è LIBRO CORTESE ( Bagheria, ’71 ) .
Per G. Di Genova , ” il periodo,tra il ’47 ed il ’50,è il più fortunato di Carta .Poi la buona stella comincia a calare e diventa quel personaggio < duro da sopportare >,come dice Zavattini, ma personaggio”.
Carlo Belli scrive che ” queste forme,agitate,spiritose o placate in una fissa serenità, più che nel campo diremmo plastico,sono ancora nel dominio della poesia visiva ….” .
Per G. Frazzetto, ” la vastissima produzione di Carta è caratterizzata dalla predilezione per i piccoli o minimi formati, e per le tecniche rapide…..Troppo poeta,e non solo nel senso traslato del termine, Carta ha finito col farsi schiacciare dai crudeli ingranaggi di una società cinica,terminando la sua vita in miseria, dopo anni di vera
bohème ” .CARTA
il futurista
Da ” La Sicilia ” del 28/Nov/02,a firma Laura Oddo,riportiamo in parte :
“Su tutto domina il segno asciutto ed ironico,le trasparenze dell’acquarello, i cromatismi sapienti . Aderì con D’Avila,Barella,
Belli,Ketoff,Monachesi e Tano al secondo futurismo,riuscendo ad operare una sintesi felice tra poesia e letteratura ( manifesto poesia murale del ’36) . Marinetti definì i suoi interventi poetici ” poesia sintetica,astratta,mosaica” in quanto connotati da un grado minimo di linguaggio……nel ’40 si trasferì a Pavia,divenendo amico di Pugliesi,
Valsecchi e Ravasenga .Tornato a Roma , fondò la “Casa rossa” cui aderirono Perilli, Dorazio,Vespignani,Guttuso,Omiccioli,Ungaretti,
Aleramo,Mazzullo .Partecipò anche al Gruppo Primordiali Futuristi di
Antonio Sant’Elia, dal nome del grande architetto futurista morto…..
Partecipò anche ad un film in veste d’autore, dal titolo ” La collina degli stivali ” .Il valore,la vivacità di questo lavoro si percepisce appieno nelle carte esposte .
Zavattini ebbe a scrivere per lui : ” Ti vedo con una certa ammirazione nella tua modesta casa a creare coi pennarelli , per dodici ore quotidiane,labirinti sempre diversi,ci stai volentieri in prigione,
ti sento quando gridi che vuoi diventare ricco per dipigere a olio su enormi tele. E poi ? I fogli probabilmente hanno cominciato a guardarti male ” .
Il Comune di Priolo vorrà omaggiarLo con una Retrospettiva nel novantesimo anniversario della nascita ?CARTA, artista fuori dalle mode
Da ” Il Giornale di Sicilia” del 3 Dicembre/02 , a firma Emilia Valenza,
riportiamo :
“Chi Lo ha conosciuto non esita a definirLo un uomo d’eccezione.
L’immagine che se ne ricava dalle fotografie che lo ritraggono è quella di una figura eccentrica,la maschera dell’artista stravagante,capellone,
barba lunga ed arruffata,occhio tagliente….
Carta forse era proprio così e così di sè scriveva : <…i giorni me li passo disadorno e impuro> cercando nei versi una metafora alla sua libertà d’artista . Interprete curioso di diverse stagioni artistiche,
fu soprattutto <un candido lebbroso portato a spasso dalla poesia >…..
Nei suoi fogli,concessi dalla figlia Elisabetta, le maschere sembrano
occupare un posto a parte, come se si trattasse di un genere che l’artista intendeva ripetere per esorcizzare fantasmi o per nascondere verità. Hanno un sapore fortemente evocativo,emergono dall’inconscio e si trasformano in incubo. Sono l’apparenza del suo disagio,le icone angosciate di un’esistenza troppo difficile ” .DIARIO DOC- SIRACUSA
SABATO 8 MARZO 2003CARTA, il genialoide
Sebastiano Carta,nato il 3 Marzo 1913 a Priolo(Sr) e morto a Roma
il 22 Dicembre 1973,all’età di 60 anni compiuti, fu romano d’adozione,
in quanto il padre,guardia di pubblica sicurezza,ottenne un impiego presso il Ministero degli Interni proprio a Roma , dove frequentò il Liceo Classico ( pare che tra i suoi insegnanti ci fosse Giuseppe Ungaretti ! ).
Suo unico erede : la figlia, l’attrice Elisabetta Carta.CARTA , misconosciuto futurista
Scorsone sottolinea ” l’ammirazione che aveva per Prampolini e l’influenza che ebbe su di lui l’espressionismo tedesco ” e per Ferlito fu ” poliedrico e versatile ” .
“….. i miei temi cercano di narrare ,o meglio evocare immagini di una realtà dove i nostri sentimenti siano trattati come minerali,dove le molecole possano persino dimostrarsi ciniche e spietate ” .