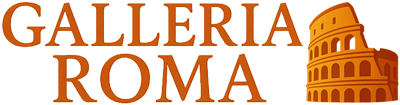Alessandro Abate è nato nel 1867 a Catania, dove è morto nel 1953 all’età di 86 anni
Allievo di Antonio Gandolfo e del Marinelli, frequentò L’Accademia S.Luca. A Roma esordisce nel 1894 alla Mostra Nazionale, cui segue Parigi al Grand Prix del 1829, a Santiago nella Galleria d’Arte Moderna un suo quadro dal titolo Eppur si muove .Nel 1902 espone alla Promotrice di Torino. Dal sito www.exibart.com si riporta in parte :
” La formazione, dalla fine degli anni ´80 all’inizio del secolo XIX, avviene prima a Catania con Antonio Gandolfo(Catania 1841 – 1910),poi a Napoli con Vincenzo Marinelli (S. Martino/PZ 1820 – Napoli 1892), infine a Roma, pensionato dal Comune di Catania, con Francesco Jacovacci (Roma 1838 – 1908) e presso le scuole del Museo Artistico Industriale.
Gli esordi degli anni Novanta, caratterizzati dalla tematica sociale di tono patetico attinta dal suo primo maestro catanese e scanditi dalla partecipazione alle esposizioni nazionali e locali, quali la Belliniana di Catania del 1890, la Nazionale di Roma del 1895, la Quadriennale d´arte decorativa moderna di Torino del 1902 e l´Esposizione Agricola Siciliana di Catania nel 1907, che ne consacrò la fama di decoratore dell´ “Arte nuova” riservandogli una parete della < Mostra di Belle Arti e Fotografia>.
Il rientro definitivo a Catania, nei primi anni del Novecento, dove lavora stabilmente, tranne brevi assenze per lavori decorativi in provincia di Siracusa e di Messina e, dalla fine degli anni ´20 al 1940 per committenze pubbliche dei rispettivi governi a Tripoli, a Tunisi e ad Alessandria d´Egitto. A fianco di una costante e intensa produzione di opere da cavalletto dalla vena intimistica e idilliaca, con una netta predilezione per il ritratto e le scene d´ambiente domestico, Abate realizza fin dentro il terzo decennio del `900, decorazioni di ispirazione liberty per dimore private, richiestissimo dall’aristocrazia e dall´alta borghesia catanese, e lavori per la committenza ecclesiastica.
Stimato pittore e apprezzato decoratore, Alessandro Abate,figlio di Carmelo e Anna Reitano, benestante cinquantenne, realizzò a Catania, tra il 1915 e il 1918, negli anni della grande guerra, al n. 12 della Via Vallone al Borgo, attuale via Carmelo Abate, il palazzotto in cui alloggiare al piano terra e lavorare al primo, il cui progetto aveva significativamente commissionato all´affermato ingegnere Tommaso Malerba. Quel palazzotto, ad oltre cinquant´anni dalla morte del pittore, con la raccolta delle opere che custodisce, auspichiamo che possa essere guadagnato alla pubblica fruizione quale “casa museo” per il suo portato testimoniale, sapientemente conservato dalla nipote Maria Salmeri
Categoria: News
-

ABATE ALESSANDRO
-

LETO ANTONINO
La prima formazione di Antonino Leto si compie alla scuola di Luigi Barba e di Luigi Lojacono. Ma l’incontro con quest’ultimo suscita una spontanea adesione alla pittura di paesaggio e ai dettami del vedutismo naturalistico, approfonditi dal soggiorno napoletano. Leto infatti, ancora una volta si mostrerà recettivo alle innovazioni, preferendo accompagnarsi ai pittori del gruppo di Resina, una libera unione fondata da Giuseppe De Nittis, Marco De Gregorio, Federico Rossano e il toscano Adriano Cecioni che vi portò il contributo teorico e le sperimentazioni dei macchiaioli. La scuola di Resina, aveva una poetica innovativa indirizzata verso una rappresentazione del paesaggio più libera, secondo una fedeltà al “vero” reso emozionante. E’ a questo periodo che risalgono gli studi sul colore e sulla luce delle opere vesuviane. Nel 1874 vinse il concorso per il Pensionato Artistico di Roma. Qui strinse amicizia con Francesco Paolo Michetti. Per ragioni di salute chiese il trasferimento al Pensionato Artistico di Firenze dove entrò in contatto con i macchiaioli, approfondendone la lezione già appresa a Resina. Al termine del pensionato si recò a Parigi, dove lavorò per il mercante Goupil e diventò amico di De Nittis. Ma anche il soggiono parigino è interrotto per la salute malferma dell’artista, che nel 1880 rientra in Italia, soggiornando prima a Portici e poi a Monreale e a Palermo. I bozzetti preparatori presso la Galleria d’arte Moderna di Palermo e i relativi affreschi recentemente scoperti nella Villa Florio dei Colli lo ritraggono insieme ai suoi protettori nel clima festoso della belle époque.Tornò in Italia nel 1880, lavorò anche come freschista e realizzò dipinti su commissione. Nel 1882 si stabilì a Capri, e lavorò con fede e passione, noncurante della malferma salute e continuò a partecipare con successo alle principali mostre nazionali ed estere. I luoghi del mare, i faraglioni, le grotte, le spiagge sui piccoli porti, i paesaggi incantati delle isole, sono i protagonisti dell’ultimo periodo di Leto che si svolge a Capri, dove egli si trasferisce definitivamente nel 1899.Dieci anni prima, nel 1889, era presente all’Esposizione Universale di Parigi. I suoi quadri di marine, pescatori e scogli furono per la maggior parte acquistati da ricchi collezionisti stranieri. Sono dipinti che” aprono l’animo alla gioia della vita”. A Roma, Torino, Nizza, Londra, Monaco e Venezia egli ottenne i più lusinghieri successi. Nel 1914 all’Internazionale di Venezia venne tenuta una mostra retrospettiva nella quale furono comprese ventotto sue opere. Notevoli: Studio; Capri; Piazza della Signoria di Firenze; Studio di Signora; Scogli e mare; Piccola marina; Testa di donna, appartenente al pittore Federico Michele; Cava dei Tirreni. Si rammentano: Un ventaglio( tempera), Zucche (acquarello), Pescatore napoletano (pastello).
-

LOJACONO LUIGI
Palermo 1810-1880
Non essendo ancora stati portati avanti studi approfonditi sulla figura di Luigi Lojacono, risultano scarse le notizie relative alla vita ed alla produzione artistica. Padre del più noto Francesco, fu allievo di Giuseppe Patania e lavorò nello studio di Salvatore Lo Forte. Superò l’iniziale formazione neoclassica a contatto con le nuove istanze romantiche, grazie anche alla partecipazione attiva alle imprese risorgimentali e garibaldine.
Fu autore di ritratti , molti dei quali oggi alla Biblioteca Comunale di Palermo, e di soggetti religiosi, ma soprattutto si distinse per le numerose scene di battaglia ispirate alla pittura seicentesca di Salvator Rosa e Micco Spadaro.
La sua attenzione alla resa realistica si accentuò in seguito al contatto diretto avuto a Napoli nel 1850 con Filippo Palizzi. Negli anni sessanta, forse sotto l’urgenza dell’esperienza diretta dell’impresa dei mille in Sicilia, le sue battaglie si fanno più attente alla realtà contemporanea, come testimoniano Bersaglieri e briganti (1864), della Civica Galleria d’Arte Moderna di Palermo e Garibaldi a Gibilrossa (1862), in collezione privata, nel quale si fa più evidente lìinfluenza dei Palizzi, ma anche quella dei macchiaioli con i quali può avere avuto contatti in quegli anni di scambi frequenti a livello nazionale, favoriti anche dai frequenti spostamenti degli artisti attivamente impegnati nelle battaglie per l’indipendenza.
Fu maestro di molti pittori tra i quali, oltre il figlio Francesco, anche Antonio Leto. Nel 1863 vinse la medaglia d’argento all’Esposizione di Belle Arti di Palermo con la Battaglia di Milazzo.
Sue opere pure presso Chiesa di S. Francesco di Paola(TP).
Scrive M.C. i Natale : ” Le sue opere sono quasi sempre di piccole
dimensioni,talvolta di formato ovale, caratterizzate da scene concitate,con soldati che agitano le spade…..” .Degna di menzione la Retrospettiva su Luigi e Francesco Lojacono alla GAM (PA,28 Gennaio,1996) .
Degna di menzione la Retrospettiva alla GAM (PA,28 Gennaio 1996).
-

Paolo Orsi, “Schliemann” di Siracusa
Se è vero che il grande studioso ed archeologo Paolo Orsi (Rovereto 1859 – 1935), venne a Siracusa in seguito ad un concorso pubblico che cambiò la sua residenza fiorentina con quella aretusea, è anche vero che vi spese ben cinquanta lunghi anni della sua vita e che, dalla città di Archimede, non lo strapparono mai le offerte lusinghiere della direzione del Museo di Napoli o i continui inviti a ricoprire le prestigiose cariche universitàrie di Torino, Pavia, Milano e Catania. Siracusa fu, per l’Orsi, la patria d’elezione, alla quale, come egli stesso ebbe a dichiarare, “andava debitore della sua gloria”. Archeologo e studioso di notissima fama, Paolo Orsi antepose sempre alla tranquillità dell’insegnamento il travaglio di ricerche lunghe e pazienti, la fatica di indagini silenziose e laboriose. Ma proprio con quel lavoro tenace, caparbio e scrupoloso, egli gettò le basi delle moderne conquiste archeologiche che gli fecero meritare, a ragione, il titolo di “Schliemann della Sicilia”. Orsi giunse a Siracusa, appena trentenne, nel 1888, con una salda preparazione scientifica, conseguita prima a Rovereto, sua città natale, e poi a Padova, Vienna e alla Regia Scuola Italiana di Archeologia. La sua preparazione nasceva dalla guida di grandi e valenti maestri
come Fortunato Zeni, dal quale apprese i primi rudimenti di numismatica romana e medievale, il Benndorf, l’Hirschfeld e il Pigorini, di cui per quarant’anni fu amico e discepolo prediletto. Accolto, non senza diffidenza, nella Reale Sovrintendenza di Siracusa, dal Cavallari, direttore generale alle antichità di Sicilia, attratto irresistibilmente dalle origini greche della città e dal fascino dei suoi innumerevoli reperti archeologici, Orsi iniziò subito una serie intensis-sima di ricerche sul terreno e sul materiale che gli consentì di tracciare il primo quadro storico, sistematico delle originarie culture dei Siculi, della Sicilia preellenica, dei famosi Sikeloi.
Le nostre conoscenze storiche su questo antico popolo abitatore della Sicilia e dei siti siracusani si arrestavano, infatti, alla fine del IX e agli inizi dell’VIII secolo avanti Cristo quando, grazie all’intensificarsi dei commerci, arrivarono sulle coste sicule i primi nuclei di coloni greci. I
tentativi del Cavallari, del barone Von Andrian, dello Schubring, erano assai lontani dalla soluzione del problema, che venne invece affrontato in pieno dall’Orsi, con tenacia e costanza. I quattro periodi in cui egli fissa le fasi salienti di tale civiltà ci permettono di seguire questo popolo paleosiculo nella sua unità culturale ed etnografica, la quale si manifesta nei sepolcri e nei riti funebri. Siculi e sicani sarebbero in fondo delle genti appartenenti alla stessa famiglia, pervenute probabilmente nell’isola in epoche diverse, ma formanti una completa unità etnica: un ramo, insomma, della stirpe mediterranea, irradiatasi dalle coste dell’Africa su tutto il mezzogiorno dell’europa occidentale e soprattutto in Sicilia. Ma l’attività dell’Orsi non rimase circoscritta al solo problema delle origini. Le sue ricerche sulla civiltà greca in Sicilia, e particolarmente a Siracusa, sono state grandissime. I suoi studi sull’Athenaion di Siracusa costituiscono oggi una vera conquista scientifica. Il suo interesse, altresì, fu indirizzato principalmente verso la scoperta e la conoscenza di
luoghi sacri e pubblici, come le necropoli greche e l’Olimpieion di Siracusa.
Effettuò personalmente esplorazioni arditissime e tenaci delle necropoli di Pantalica, Cassibile, Megara, Castelluccio, Thapson, Licodia, Valsavoia, salendo e scendendo dagli Erei e dagli Iblei. Al suo acuto occhio di osservatore preparato, le tombe si scrollavano la polvere del tempo e cominciavano a parlare, principalmente con la massa del vario materiale retituito alla luce, dopo un silenzio di millenni: disparati avanzi di piccole industrie domestiche, cocci di ceramiche con incisioni geometriche, campioni vascolari con elementari decorazioni, suppellettili varie come coltelli litici, asce basaltiche, fibule, armi, corredi mortuari. Alla ricerca di tutto ciò, lo si vedeva spesso su balze inaccessibili, avvolto nel suo pesante mantello nero, immobile, con lo sguardo perduto sulle rocciose distese, assistito sempre dal suo fidatissimo collaboratore, professor Rosario Carta. Profuse molte energie sugli studi praticati nella grande catacomba siracusana di San Giovanni, alla quale consacrò ben cinque campagne archeologiche, ricchissime di risultati.
Ma le sue attenzioni si estesero anche ai cimiteri che si trovavano nella regione occidentale di Akradina, Santa Maria, Santa Lucia (ex Vigna Cassia), di cui rivelò topografie, forme tectoniche, elementi decorativi. Da essi, trasse fuori grandi risultati che gli permisero di ampliare enormemente lo studio del simbolismo delle pitture e la minuta descrizione dei suppellettili dei sepolcri, che lo portarono a capire le più importanti consuetudini funerarie di questi nostri antichi e sorprendenti antenati. Studiò un gruppo numeroso di minori ipogei disseminati lungo la falda orientale della terrazza di Akradina, di cui illustrò il problema del cristianesimo primitivo e del lungo travaglio della chiesa siracusana nei primi secoli della sua vita. Si trattava in genere di cimiteri ipogeici, sperduti nella solitudine di vaste campagne, ricchi di elementi epigrafici e decorativi.
Queste incessanti ricognizioni topografiche, non solo lo mettevano a diretto contatto con le vetuste reliquie della civiltà sicula e greca, ma gli permisero di annunciare, con vero stupore degli studiosi di archeologia, che la sola provincia di Siracusa comprende un centinaio tra grandi e piccoli cimiteri di età greca, romana e cristiana. Cimiteri disseminati nell’immensa campagna che si stende dalla marina costiera di Noto a Canicattini Bagni, a Cava d’Ispica, Spaccaforno, Licodia Eubea, Floridia, Cassibile, Modica, Buscemi, Palazzolo Acreide. Nella carta topografica dei cimiteri cristiani, essi parlano, per merito dell’Orsi, con precisi rilievi monumentali, illuminando ed integrando leggende agiografiche che sembravano, fino ad allora, destituite di ogni attendibilità storica. Innamorato di Siracusa e della storia ellenica, questo solitario archeologo trentino, dalla figura alta, asciutta, volitiva, sempre in tenuta da campagna, dal collo chiuso, dagli stivali affibbiati, aveva sempre le tasche piene di taccuini e di lapis. Su questi celebri taccuini (oggi custoditi presso la Sovrintendenza archeologica regionale di Siracusa), dalla tipica copertina nera, che contenevano circa duecento fogli ciascuno, appuntava meticolosamente i dati di scavo, ma anche le sue impressioni personali, i suoi stati d’animo, le sue ansie, le sue paure, le sue gioie, le sue emozioni di fronte al grande mistero della storia antica e delle tracce di quegli uomini che di essa erano stati protagonisti. Ma oltre a questi libretti vi è la mirabile opera degli inventari, tracciati tutti di suo pugno, dove si trova, un materiale prezioso, di cui ci auguriamo tutti, nell’interesse della scienza, che ne vanga prima o poi curata la pubblicazione. Sono essi la testimonianza del nostro passato, al quale, pur nella nostra civiltà trasformata e rivoltata da mille eventi e mutazioni, non possiamo che riconoscerci, non possiamo che rintracciare le nostre prime radici. E di questo passato egli faceva un paziente lavoro di classificazione, di minuzioso controllo durato diversi anni. Si può ben dire a riguardo che in questo campo il suo contributo è stato grandissimo tanto da meritargli un posto eminente nella storia della moderna archeologia e da fargli ottenere nel 1896 la nomina a membro dell’Accademia dei Lincei e nel 1924 quella di senatore. Ma Orsi non si gloriò mai di questi titoli, l’amore per la storia e l’archeologia gli riempì talmente la vita da indurlo perfino a rinunciare alle gioie di una propria famiglia. Conservò sempre consuetudini semplici, francescanamente severe e riservate, che si stemperavano solo nel ricordo degli anni, sudatissimi ma felici, vissuti nella nostra città, nella “sua” Siracusa.Al suo nome è intitolato il Museo Archeologico Regionale della Sicilia. Inaugurato nel 1886 in piazza del Duomo, esso fu diretto dal 1895 al 1934 proprio dal nostro Paolo Orsi. E fu la crescita della raccolta di reperti e documenti a condurre alla progettazione di un nuovo spazio, quello attuale, nel giardino di villa Landolina. E’ stato l’architetto Minissi a disegnare la nuova struttura, inaugurata nel gennaio 1988 e costituita da due piani espositivi. In essa vive il segno tangibile del lavoro svolto per tanti anni dall’Orsi per la nostra città.
-

Memorie siracusane dalle cronache passate
Sin dalla costituzione dello Stato unitario del Regno d’Italia si ritenne necessario procedere ad una catalogazione dei beni monumentali ed artistici presenti sul territorio nazionale. I vari progetti al tempo presentati in Parlamento non ebbero vita facile, sia per la poca chiarezza sia per le farraginose sanzioni legislative. Più disegni di legge dì regolamentazione del tema si ebbero nel 1887, poi nel 1892 e ancora nel 1898 e infine si pervenne a quello definitivo del ministro Gallo del 4 dicembre 1900, che con alcune modifiche apportate dal Senato, imponeva la formazione di un Catalogo ufficiale delle Opere d’Arte. La funzione del catalogo aveva come fine precipuo la necessità di una normativa giuridica che presiedesse alla tutela del patrimonio artistico e monumentale. Ulteriori successive modifiche al testo non mutarono sostanzialmente il quadro d’insieme. Sorse pertanto la necessità da parte delle Sovrintendenze di produrre un elenco aggiornato degli edifici monumentali, che successivamente il Ministero della PI., raccolti i dati, fece pubblicare in unico elenco nel 1902, e su appositi Bollettini per provincia a partire dal 1911. In tempi in cui il nostro Patrimonio Artistico, con le recenti leggi emanate dall’attuale Esecutivo, potrebbe subire un rischioso depauperamento, giova riportare e rileggere la lettera inoltrata il 21 novembre 1916 dall’allora Sovrintendente delle Province di Siracusa e Catania, Paolo Orsi; lettera indirizzata al Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti di Roma, Corrado Ricci. Tale lettera fa da introduzione al Bollettino attinente l’Elenco degli Edifici Monumentali della Provincia di Siracusa.
-

LE LATOMIE
Queste grandi cave di materiale edilizio, ai limiti della città antica, costituirono già in antico, come ancor oggi, una delle caratteristiche più straordinarie di Siracusa. La loro esistenza in età già notevolmente antica è dimostrata da un celebre passo di Tucidide (VII 86-7), a proposito del loro uso come prigione per i superstiti della sfortunata spedizione ateniese.
« In un primo tempo i Siracusani trattarono duramente quelli che erano nelle Latomie. Questi, in molti in un luogo cavo e ristretto, dapprima furono tormentati dal sole e dal caldo, essendo il luogo scoperto; sopravvennero in seguito, per contro, le notti autunnali fredde, Che provocarono le malattie. E poiché per la ristrettezza dello spazio essi facevano tutto nello stesso luogo, e per giunta si accumulavano gli uni sugli altri i cadaveri di coloro che mori- vano per le ferite, per i cambiamenti di temperatura e per cause dello stesso genere, il puzzo era intollerabile, ed erano tormentati dalla fame e dalla sete (intatti, distribuirono loro per un mese un cotile d’acqua e due cotili di grano). E di quanto poteva capitare a chi fosse gettato in un tal luogo, nulla fu loro risparmiato. Rimasero cosi ammassati circa settanta giorni: dopodiché, tranne alcuni Ateniesi e alcuni Siciliani e Italici che avevano combattuto con loro, tutti furono venduti. Non è facile dire esattamente quale fosse il numero totale dei prigionieri, ma certo non inferiore a 7.000 ».
A molti secoli di distanza troviamo un’altra descrizione in Cicerone (Verrine, II 5, 68).
« Tutti voi avete sentito parlare, e la maggior parte conosce direttamente, le Latomie di Siracusa. Opera grandiosa, magnifica, dei re e dei tiranni, scavata interamente nella roccia ad opera di molti operai, fino a una straordinaria profondità. Non esiste né si può immaginare nulla di cosi chiuso da ogni parte e sicuro contro ogni tentativo di evasione: se si richiede un luogo pubblico di carcerazione, si ordina di condurre i prigionieri in queste Latomie anche dalle altre città della Sicilia ».
La datazione delle Latomie è difficile da stabilire, anche perché la loro utilizzazione dovette continuare per un periodo notevolmente lungo. Non si può dedurre nulla in proposito dalla notizia di Pausania (V 8, 8), secondo la quale presso le Latomie era la tomba di Lygdamis di Siracusa, il primo vincitore del pancrazio a Olimpia, nel 648 a. C. Alcune almeno di esse esistevano già nel V sec. a. C., come dimostra il racconto tucidideo, e dovevano essere abbastanza ampie, se potevano ospitare 7.000 persone, sia pure in condizioni disagiate. La loro stessa dislocazione ai margini della Neapolis potrebbe suggerire che le cave siano state sfruttate soprattutto a partire dalla creazione del nuovo quartiere, e cioè forse dall’inizio del V sec. a. C. Le Latomie sono del resto ricordate soprattutto per la funzione che assunsero in seguito, quella di prigione di stato. Dopo l’utilizzazione, forse occasionale, come prigione degli Ateniesi, quest’uso dovette divenire corrente a partire dall’epoca di Dionigi, il quale vi avrebbe rinchiuso il poeta Filosseno. colpevole di non aver sufficientemente apprezzato le opere letterarie del tiranno (Diodoro, XV 6; Eliano, Varia hisioria, XII 44). Cicerone attribuisce addirittura la loro realizzazione allo stesso Dionigi, ma altrove, come abbiamo visto, afferma che si trattava di un’opera « dei re e dei tiranni », e cioè per l’appunto di lavori compiuti in un lungo periodo, tra il V secolo e la conquista romana. Quando l’oratore scriveva, le Latomie erano utilizzate abitualmente come prigione di stato non solo per Siracusa, ma anche per le altre città della Sicilia.
Siamo informati anche di altri usi delle Latomie: di alcune di esse ci si serviva come abitazione, da parte dei ceti più umili della città (Eliano, Varia historia, XII 44); probabilmente vi si trovavano anche sedi di collegi e corporazioni, funerarie o d’altro tipo, come sembra dimostrare la presenza in molte di esse di numerosi quadretti votivi dedicati a morti eroizzati (lo stesso avviene anche ad Akrai e a Noto). È anche possibile che queste cave potessero assumere una funzione difensiva, come parrebbe dedursi dalla loro collocazione. Le più importanti Latomie sono disposte, infatti, secondo una linea quasi continua, da ovest a est, con poche aperture destinate alle vie di accesso da nord, che si potevano facilmente sbarrare in caso di pericolo. Questa linea segue grosso modo i limiti settentrionali della Neapolis, in origine non protetta da mura, sostituite forse da questo tutto sommato efficace sistema di difesa (che potè essere utilizzato, ad esempio, durante l’assedio ateniese, quando tra l’altro fu fortificato il colle Temenite).
Le uniche notizie antiche sulle dimensioni delle Latomie si trovano in Eliano, che attribuisce loro la lunghezza di uno stadio e la larghezza di due pletri (circa 200×60 m). Si tratta naturalmente di dimensioni che possono essere attribuite solo a unal singola Latomia (dimensioni simili si ritrovano, ad esempio, nella Latomia di S. Venera e nei settori più importanti delle Latomie del Casale e dei Cappuccini). Calcoli moderni attribuiscono la cubatura di 4.700.000 m3 al materiale estratto dal complesso delle cave: una cifra gigantesca, che permette di farsi un’idea dell’ampiezza dei lavori edilizi realizzati in Siracusa nel corso dell’età -classica ed ellenistica.La più grande e celebre è la Latomia del Paradiso, che è anche (- la più occidentale, adiacente al teatro e all’Ara di Ierone II. Essa raggiunge in alcuni punti la profondità di 45 m, e in età antica era parzialmente coperta: sul lato nord restano enormi blocchi della volta crollata. Nel lato nord-ovest si aprono alcune grotte, scavate alla ricerca del materiale migliore (l’ottimo calcare bianco a grana fine dei monumenti di Siracusa). Nell’angolo ovest, in prossimità del teatro, è il celebre Orecchio di Dionigi, una cavità che presenta una pianta a forma di S, e una volta a sesto acuto, alta 25 m. Il nome è dovuto al Caravaggio, che visitò la grotta nel corso del suo viaggio a Malta: in effetti, vista dall’esterno, essa ha la forma di un immenso padiglione auricolare. Ma soprattutto, il nome allude alla funzione che la grotta avrebbe avuto, grazie alle sue straordinarie qualità acustiche, che permettono di ampliare enormemente il minimo suono: il tiranno avrebbe in tal modo potuto ascoltare, da un piccolo ambiente collocato all’esterno della grotta, ogni parola dei prigionieri in essa rinchiusi.
Non è escluso che proprio questa possa essere la prigione di Filosseno: Eliano afferma infatti che il poeta era stato rinchiuso « nella grotta più bella delle Latomie, dove aveva composto il suo capolavoro, il Ciclope: grotta che in seguito aveva preso il suo nome ». Naturalmente, potrebbe anche trattarsi di un altro ambiente, come la vicina grotta dei Cordari, dalle bellissime sfumature policrome (così detta dagli artigiani che vi operavano fino a pochi decenni fa).Una galleria moderna mette in comunicazione la Latomia del Paradiso con la vicina Latomia dell’Intagliatella. Tra le due è risparmiato un passaggio, dove convergeva la strada antica proveniente da nord-ovest, che entrava sulle Epipole tramite la porta monumentale detta Exapylon (in corrispondenza della località moderna di Scala Greca). La via era seguita, per quasi tutta la sua lunghezza, dall’acquedotto antico detto del Paradiso, che entrava in città nella stessa zona.
Dall’Intagliatella si accede, tramite un arco tagliato nella roccia, alla Latomia di S. Venera, particolarmente pittoresca per la sua ricca vegetazione subtropicale. Nella parte più orientale le pareti sono crivellate da numerosissime nicchiette votive, che erano accompagnate da piccoli sacrifici e libazioni (i cui resti sono stati rinvenuti, in varie epoche, entro cavità scavate ai piedi della parete).
A est della Latomia di S. Venera è la necropoli di Grotticelli, che si affianca a una delle altre grandi vie provenienti da nord. Tra le numerose tombe scavate nella roccia sono notevoli due colombari con facciata monumentale, costituita da un frontone poggiante su semicolonne doriche. Quella più a sud è nota con il nome, fìttizio, di « tomba di Archimede » (la vera tomba di Archimede era probabilmente situata, come sappiamo da Cicerone, nella necropoli dell’Acradina, probabilmente da identificare con quella del Fusco, a ovest della città).
Altre importanti latomie si trovano a una certa distanza dal nucleo della Neapolis, più a est. Si tratta delle Latomie del Casale e Broggi, anch’esse collocate lungo la stessa linea ovest-est, e utilizzate probabilmente per la costruzione della Neapolis.
A nord di queste è un’altra importante cava, che per la sua posizione eccentrica sembra esser stata sfruttata per l’ampliamento della città in età ellenistica, testimoniato tra l’altro dall’edifìcio termale scoperto a nord della Latomia del Paradiso, lungo la strada proveniente dall’Exapylon. La stessa funzione avrà avuto la Latomia Novantieri, sita ancora più a nord.
Molto più distante, verso est, è l’altro grande complesso, noto col nome di Latomia dei Cappuccini. Si tratta di uno degli esempi più vari e impressionanti; per la sua posizione, esso va probabilmente collegato con il quartiere periferico di Tycha (da situare immediatamente più a nord). Si ritiene in genere, ma senza elementi sicuri di prova, che qui fossero stati rinchiusi i prigionieri Ateniesi dopo la sconfìtta del 412. Molto lontana, all’estremità occidentale delle Epipole, è la piccola Latomia del Bufalaro, probabilmente sfruttata per la costruzione delle mura di Dionigi e del Castello Eurialo.Veduta esterna della grotta chiamata Orecchio di Dionisio
di Jean HoüelNell’angolo della latomia sopra descritta c’è una grotta la cui pianta circolare B forma quasi una S; la larghezza all’imboccatura è di circa 20 piedi; la profondità, a partire dall’angolo sporgente a sinistra dell’ingresso fino in fondo, misura circa sessantanove piedi mentre ne misura trentadue nel punto dove è più larga (vedere la pianta); verso il centro, dove il terreno s’abbassa a partire dall’ingresso, l’altezza è di circa cinquantacinque piedi fino alla parte della volta circolare secondo le linee tratteggiate in mezzo alla pianta. Le pareti laterali di questa grotta si avvicinano curvandosi e raddrizzandosi ad una distanza di due piedi l’una dall’altra; questi muri ad arco acuto a forma di S, hanno un’altezza ed una forma tale che ne esistono pochi esemplari; di ciò solo l’apertura può fornire un’idea esatta. Osservate in questa tavola dal punto A fino al punto B. Quella successiva ne completerà la conoscenza. La zona segnata 34 sulla pianta è un avvallamento quadrato di circa venti piedi, privo di interesse. Ho notato sul muro posto a sinistra, verso il fondo di questa grotta, buchi quadrati di circa due pollici disposti in modo da far credere che una volta vi erano collocate sbarre di ferro. La loro distanza, in altezza e in larghezza, è tale che aggiungendo tavole orizzontali e verticali a queste sbarre di ferro, si potrebbe fare una scala per raggiungere una porta alta circa 40 piedi. Tale porta immetteva in un cunicolo di cui credo aver individuato l’uscita all’esterno della grotta, a 48 piedi al di sopra del suolo nella zona segnata C in questa tavola, esattamente nel punto in cui ho rappresentato un uomo dentro un paniere mentre sta scendendo per visi- tare il cunicolo. Era l’unico modo per andarvi. Le figure di questo quadro rappresentano uomini a piedi e a cavallo venuti a far echeggiare questa grotta del suono dei tamburi, delle trombe e degli spari dei fucili. Mirabella, nato a Siracusa e autore di una storia della città, c’informa che questa grotta, chiamata Orecchio di Dionisio, in origine era una cava come le altre designata con il nome di Piscidina. Ci racconta che vi si rinchiude- vano prigionieri importanti durante il regno di Dionisio e che il carceriere mettendosi in un certo punto del cunicolo, a loro insaputa, riusciva ad ascoltarne i discorsi anche se parlavano a voce bassa, per l’effetto straordinario di un’eco prodotta dalla forma della grotta. Una volta al corrente dei loro segreti, li riferiva a Dionisio. Questo è quanto si racconta, ma anche la forma appuntita della grotta, forse, ha contribuito a darle il nome di orecchio da cui poi è nata la leggenda. Fuori, all’imboccatura del cunicolo, doveva essere! una scala che conduceva al di sopra della rupe, dove si trovavano le costruzioni che completavano gli alloggi della prigione, di cui la grotta era la segreta. In questo Orecchio o Piscidina, il tiranno Dionisio rinchiuse il filosofo Filosseno, verso cui aveva mostrato tanta amicizia, perché non aveva lodato i suoi versi. Tutti sanno che Dionisio, dopo averlo tenuto prigioniero per punirlo della sua sincerità, si lasciò impietosire, lo richiamò, invitandolo a pranzo per rileggergli i versi. Ma Filosseno chiese di essere ricondotto in prigione non avendo trovato quei versi migliori. Dionisio non si offese. Ma poi, perché consultare dei filosofi quando non si vuole ascoltare la verità? Dionisio aveva molti cortigiani ma era insensibile ai loro elogi. In questa grotta e nelle altre latomie, in particolare in quel- la dei Cappuccini, Ì Siracusani rinchiusero gli Ateniesi fatti prigionieri dopo la sconfitta di Nicia e di Demostene. Furono nutriti con misere razioni di orzo e acqua e vi morirono di stenti. I prigionieri che non erano ateniesi furono venduti all’incanto come schiavi.
Veduta interna della grotta chiamata Orecchio di Dionisio
di Jean HoüelPossiamo verifìcare, contemplando la parte superiore di questa grotta, se mi sono sbagliato quando ho affermato che l’entrata aveva qualcosa di straordinario. Si può facilmente riscontrare che il soffitto circolare può provocare l’eco. Eco che sarebbe più chiara e più forte se le pareti della grotta non fossero ricoperte in più punti da piante e muschi alimentati continuamente dall’acqua di un canale costruito su questa grotta e filtrata dai pori della pie- tra. Tale vegetazione nuoce alla ripercussione dei suoni. La fama di questa eco è tanto vasta che si considera privo di valore il soggiorno a Siracusa se il visitatore, siciliano o straniero, non sia andato a sentirne gli effetti. Coloro che visitano la grotta sono già preparati: alcuni vi scendono con strumenti musicali che producono improbabili cacofonie, seppure non prive di una loro armonia. La mescolanza dei suoni produce risultati singolari più o meno graditi ai visitatori. Altri portano pistole o fucili e a questo punto l’effetto dell’eco è così violento che a stento si può sopportare; un orecchio delicato rischierebbe addirittura la sordità. Ho rappresentato in questa stampa alcuni cacciatori che per la festa di San Nicola hanno sperimentato quanto ho detto. Nel momento in cui l’uno spara, l’altro soffia in un corno e provoca un rumore infernale. Visitando questa grotta ho potuto ammirare l’arte con cui è stata costruita. Ho potuto constatare la stessa cosa visitando le grotte vicine segnate sulla tavola con CD. Si osserva nelle pareti il modo regolare e preciso con cui la pietra è stata cavata rispettandone gli strati, l’altezza e il livello. Questo metodo è rigorosamente riscontrabile, ovunque. Ciò prova come presso questa gente, nei secoli in cui risplendevano le belle arti, tutto era fatto con estrema cura, precisione e nel rispetto del dettaglio. Le grotte CD sono attualmente abitate da uomini occupa- ti nella fabbrica di salnitro. Le fornaci, i fuochi, i vapori, rendono queste belle grotte molto simili ad antri infernali. Sono ampie e molto alte. I soffitti ineguali sono sostenuti da pilastri di diversa grandezza che si sono mantenuti anche dopo aver scavato le caverne. Questi pilastri rudimentali hanno asperità tali che associate all’irregolarità del terreno provocano effetti particolari sia all’ingresso che in fondo alla grotta. Effetti che diventano sempre più pittoreschi, per la presenza di massi enormi di roccia che, nel tempo, si sono staccati dal soffitto o dai fianchi delle grotte; massi che giacciono riversi presentando facce ed angoli con luci ed ombre così stupefacenti da ricordarsene sempre, anche dopo aver lasciato questi luoghi. La mattina o il pomeriggio, il sole penetra in questi antri producendo un crepitio di luci. I raggi, convergendo su un punto, sfavillano negli interstizi irrorando di una luce chiarissima anche il fondo delle grotte. La luce, al pari del rumore, si ripercuote nelle cavità irregolari e profonde rifrangendosi sulle rocce. Provoca agli occhi dello spettatore effetti simili a quelli prodotti sulle orecchie dal suono dell’eco quando si perde in lontananza. Provate ad immaginare questi giochi di luce e l’intera varietà di colori che il sole, nel suo cammino, produce sulle rocce rese irregolari dalle spaccature: ci si accorgerà quanto sia interessante e suggestivo un tale spettacolo agli occhi di un pittore sensibile.
-

Jatti e jattareddi
Nei modi di dire e nei proverbi siciliani del passato il gatto domestico generalmente si indicava con la forma al femminile, senza specificare il sesso: Quannu ’a jatta nun pò jùnciri a la sajmi (per sincope del volgare SAGIMEN = strutto, grasso) dici ca feti; Quannu ’a jatta nun c’è ’i surci abballunu…, al contrario di altri animali come il topo o il cane che si indicavano al maschile: ’A jatta mi talìa e ’u surci mi nichìa (mi indispettisce, mi irrita. Dal francese NIQUE = disprezzo), ’Ssiri ’u cani c’’a jatta e così via.
Per la tradizione popolare il periodo di gestazione della gatta durava quanto quello dell’allattamento: ’A jatta tri misi porta e tri misi allatta.
Spesso le gatte assumevano il nome della loro Patrona, Santa Marta.
Per comunicare con loro si usavano delle voci onomatopeiche: Cci-chissi!, cci-chissi! Per scacciarle, Muci!, muci! o Mucidda!, mucidda (sta per micia o micetta) per farle avvicinare.
Sicuramente i gatti di una volta dai loro padroni non venivano trattati così bene come quelli di oggi, L’animali si trattunu d’animali si diceva. Avendo però la funzione di catturare i topi, a differenza di altre bestie, un certo privilegio l’avevano: si tenevano dentro casa e si davano loro, invece di buttarli, tutti i rimasugli dei pasti giornalieri. Questa consuetudine, se riferita all’uomo che usava dare in abbondanza ai propri simili oggetti di scarso valore, si indicava con l’espressione N’hanu avutu cani e jatti, cioè tutti. Invece quando ci si intestardiva a non volere fare alcuna concessione a chicchessìa si ribadiva: Nun cci nesci nenti p’’a jatta.
Nonostante si cibassero soltanto degli avanzi, i gatti domestici si ingrassavano facilmente, per questo le ragazze snelle, che spregiatamene venivano tacciate di eccessiva magrezza, difendevano la loro gracilità dicendo: ’A carni sta bona â jatta.
Guai a fare assaggiare ai gatti cibi saporiti, non si toglievano di dosso: A la jatta ca licca lu spitu (spiedo) nun cci dari carni salata. Riferito all’uomo, il proverbio consigliava di non affidare a qualcuno qualcosa di cui si sapeva che fosse smanioso di possedere. La facilità dell’organismo dei gatti di assimilare il cibo è testimoniata dall’antica usanza di tagliare loro nelle prime settimane di vita il ciuffetto di peli posto all’estremità della coda detto scialanca (Dal francone CHÂLE, a sua volta dall’hindi SHAL, pronuncia sciaal = drappo con frange + HANKA = parte posteriore del corpo.) Si credeva che se non venisse reciso i gatti sarebbero diventati insaziabilmente voraci.
Il rapporto per niente affettuoso tra uomo e gatto ha dato origine a diverse locuzioni proverbiali oggi desuete. ’Ssiri ’na jatta significava essere litigioso, pronto a graffiare, per cui si raccomandava di Nun pigghjari jatti ’n vrazza (nelle braccia) e di non accarezzarli: A li jatti cchiù l’allisci, cchiù la cura cci crisci, un detto che in senso figurato vuol dire: A certa gente più si fa del bene e più si è ricambiati con il male. La stessa accusa di ingratitudine è contenuta nel modo di dire Fari ’u panicottu (in provincia ’a minestra) a li jatti che, metaforicamente, significa: è inutile affaticarsi per gli altri.
Addirittura di quelle persone che, anche quando credevano di fare del bene facevano del male, si diceva Fannu comu ’a jatta ca quannu accarizza sgranfugna (graffia. Letteralmente affonda le granfie, cioè gli unghioni; dal longobardo KRAMPF = uncino + l’epitesi verbale. La S in questo caso ha valore intensivo).
E a proposito di graffiare, anche la donna siracusana veniva identificata con la gatta: ’A sarausana è comu ’a jatta, prima t’alliscia e poi ti ’ratta (gratta).
I proverbi e i modi di dire del passato mettevano in risalto più i difetti che i pregi dei gatti. Come per i cani, così anche per i gatti, sconsigliavano di tenere in casa quelli rossicci che ingiustamente erano considerati inaffidabili: Di pilu russu né cani, né jatti. Dare a qualcuno l’epiteto di Testa (o mirudda = midolla) di jatta significava accusarlo di non avere cervello.
Si è esagerato o si è voluto generalizzare nel definire la gatta un animale puzzolente (Di lu fetu di la jatta lu diavulu si scantau) così come non risponde al vero che tutti questi animali si lamentassero sempre, anche quando avevano la bocca piena di cibo buono: Fari comu la jatta ccu lu purmuni (carne, letteralmente polmone) ’m mucca. Sicuramente il detto trae origine dall’opportunità di biasimare il comportamento di quelle persone che non sono mai contente, neanche quando hanno tutto.
Un senso di predestinazione è contenuto nel proverbio Cu’ è figghiu ’i jatta, surci ha’ pigghiari
con cui si era soliti indicare, più con compiacimento che con rassegnazione, le fanciulle che seguivano le madri sulla cattiva strada (’a via di l’acìtu).
Che non bisognasse aver fretta negli affari o nelle cose importanti era rilevato da un adagio che ha il corrispondente nella lingua italiana: ’A jatta priscialora (frettolosa, da PRESCIA, a sua volta dal latino parlato PRESSIAM = fretta) fa ’i jattareddi (o ’i figghi) orbi. Con il termine jattareddi, oltre ai gattini, i nostri anziani, medici di famiglia compresi, chiamavano, perché avevano lo stesso suono, i sibili che gli asmatici e chi era affetto da bronchite emettevano per difficoltà di respirazione, però ’i jattareddi raperu l’occhi si diceva di quelle persone che si erano scaltrite e non si lasciavano più ingannare.
Alcune locuzioni proverbiali che mettevano in evidenza gli aspetti positivi, ma sarebbe meglio dire le abilità, di questo animale domestico si usavano in senso metaforico per fare rilevare le capacità o la furbizia di alcune persone.
Di chi usciva sempre bene da situazioni difficili o mostrava di possedere una vitalità eccezionale si diceva: Havi setti spiriti comu ê jatti. Il numero sette nelle espressioni popolari ha carattere sacrale e sta ad indicare una misura indeterminata.
Un modo di dire, equivalente a quest’ultimo nel significato, è: Càdiri sempri â dritta comu ê jatti. Esso trae origine dalla capacità innata dei gatti di correggere la posizione del corpo durante le cadute da altezze notevoli uscendone indenni o tutt’al più riuscendo a riportare solo danni minimi.
Un altro privilegio di questo felino è costituito dagli occhi particolari. Riferita a certe persone, l’espressione Avìri occhi ’i jatta sottintende la capacità del gatto di adattare, dilatandola o restringendola, la pupilla (lineare di giorno, ovale di notte), riuscendo a vedere anche di notte al buio quando il comune occhio umano non distingue nulla.
Nella nostra tradizione popolare il gatto era anche simbolo della frode. La locuzione Fari ’a jatta morta allude al modo con cui questo animale quando vuol catturare una preda si mostra mite, fa finta di non vedere o addirittura si distende come se fosse morto per poi sorprendere con un balzo improvviso la vittima predestinata. Questo modo di dire siciliano ha il corrispondente italiano nel detto “Qui gatta ci cova” che equivale a: qui c’è sotto un inganno.
A Ferla, a chi per non compromettersi faceva lo gnorri, fingendo di non capire o di non sapere niente, si rivolgeva il detto Nun fari ’a jatta ’n cucuzza (letteralmente: non fare il gatto nella zucca) che equivale a quello siracusano Nun fari ’u babbu ppi’ nun pajari ’u daziu.
E concludo con un augurio: spero che a leggere questo articolo siano di più dei miei soliti quattru jatti. -

TEMPIO DI APOLLO
Poco a est del ponte che unisce l’isola alla terraferma, nel largo XXV luglio, sono i resti imponenti del tempio di Apollo. L’identificazione del culto è assicurata dall’iscrizione incisa su uno dei gradini, ma nonostante questo l’edifìcio è stato attribuito anche ad Artemide, in base a un passo di Cicerone già citato in precedenza, secondo il quale tra i molti templi che esistevano nell’isola i più notevoli erano quelli di Diana e di Minerva. Tale notizia è stata meccanicamente riferita alla situazione attuale di Ortigia, dove esistono in efletti i resti di due templi, il nostro e quello incluso nella Cattedrale, identificato con il tempio di Atena. È però evidente che Cicerone può benissimo riferirsi, quando parla del tempio di Diana, a un edificio scomparso. Sulla questione torneremo a proposito del tempio di Atena: in ogni caso, non v’è motivo di conservare, per il nostro tempio, l’attribuzione a Artemide, e neppure è accettabile la soluzione di compromesso che collega l’edificio ad ambedue i culti, sulla base di una presunta affinità tra di essi. È nota l’importanza del culto di Apollo a Corinto, madrepatria di Siracusa (dove si conserva un tempio del dio assai simile a quello di Siracusa).
Il tempio, incluso entro un quartiere medievale, è stato liberato definitivamente tra il 1933 e il 1945. Sono conservate in piedi due colonne del lato sud, con un tratto dell’epistilio, e i tronconi delle altre colonne su questo stesso lato e sulla fronte est. Resta anche un tratto del muro della cella a sud. Il tratto occidentale del basamento è di restauro.L’edificio, molto allungato (m 58,10×24,50), come del resto tutti i templi arcaici di Sicilia, è costruito in blocchi di arenaria, e poggia su poderose sostruzioni in opera quadrata, profonde 2,30 in. La peristasi comprendeva 6 colonne sui lati brevi e 17 sui lati lunghi, con enfatizzazione appunto della dimensione longitudinale. Le grandiose colonne * monolitiche (a volte completate con tasselli di riporto) misurano, con il capitello, 7,98 m d’altezza (i soli fusti 6,62) per un diametro di 2,02 m (colonne di facciata) o 1,85 (colonne dei fianchi): ognuna di esse pesava circa 40 tonnellate. Gli intercolumni sono strettissimi (il tempio quindi si definisce tecnicamente « picnostilo ») e variano considerevolmente, dai 3,55 m dei fianchi ai 4,15 dell’intercolumnio centrale della facciata (gli altri della facciata sono tutti diversi tra loro). Sui lati lo spazio tra le colonne è addirittura inferiore al diametro dei fusti. Ne risulta l’impossibilità di realizzare un rapporto di euritmia con il fregio: i triglifi, cioè, non cadevano in corrispondenza dei diametri delle colonne. Come sempre nei templi più arcaici, l’architrave era altissimo: 2,15 m, oltre un quarto dell’altezza delle colonne. L’architrave è internamente incavato, e in origine era completato in legno: altra caratteristica di grande arcaismo.
La parte alta del tempio era decorata da splendidi rivestimenti di terracotta, e di terracotta era anche la decorazione centrale del frontone, un Gorgoneion alto 1,70 m, e probabilmente gli acro-teri laterali (forse delle sfingi). In pietra era invece l’acroterio centrale, una figura di cavaliere di cui si sono conservati alcuni frammenti.II complesso centrale del tempio (sekós), lungo 37,20 e largo 11,60 m, era preceduto da un secondo colonnato, che sottolineava enfaticamente la facciata principale: come in molti templi arcaici della Sicilia, infatti, l’aspetto della frontalità è molto accentuato, e corrisponde all’assenza dell’opistodomo, simmetrico al pronao nei templi greci, che è sostituito da un àdyton aperto verso la cella. Questa era anch’essa molto allungata (24,60×11,60 m), e suddivisa in tre navate da due file di 7 colonne su due piani, delle quali sono stati scoperti pochi resti. Sulla faccia verticale del gradino più alto del lato est, a sinistra, è incisa un’iscrizione arcaica, lunga circa 8 m, certamente contemporanea alla costruzione (la scala,, centrale di accesso ne tenne conto, ed è quindi posteriore). Il testo, che presenta alcune difficoltà, si può tradurre così: « Kleomede fece per Apollo (il tempio), il figlio di Knidieidas, e alzò i colonnati, opere belle». Si tratta di uno dei rari casi in cui si conosca il nome dell’architetto, il quale sottolinea l’importanza del colonnato in pietra, opera per quell’epoca eccezionale. Il tempio, infatti, è certamente il più antico periptero dorico della Sicilia, e uno dei più antichi conservati in assoluto, ispirato, con varianti locali, all’architettura di Corinto (assai vicino è, appunto il tempio di Apollo di Corinto). La cronologia può essere fissata al primo quarto del vi sec. a. C.
Sui lati sud e ovest sono conservati resti del muretto che delimitava il témenos (area sacra) del santuario. Inoltre, a ovest, sono visibili i resti di una torre e di un tratto di mura, probabilmente bizantine, che si addossarono al tempio. -

Teatro greco
Il teatro di Siracusa, come si presenta attualmente, è il risultato di un radicale ampliamento e rifacimento, realizzato nel corso del III sec. a. C. da Ierone II. È però verosimile che il più antico teatro, la cui esistenza è testimoniata a partire dal V sec. a. C, occupasse, la stessa posizione. Una notizia risalente al mimografo siracusano Sofrone, vissuto nella seconda metà del V sec. a. C., ci da il nome del’architetto del più antico teatro: Damocopos, detto Myrilla_(Eustazio, Schol. ad Odyss., III 68). Diodoro ricorda che Dionigi_ giunse a Siracusa da Gela, nel 406 a. C nel momento in cui i cittadini uscivano dal teatro (XIII 94): questo infatti era utilizzato, come ovunque in Grecia, per le riunioni” bell’assemblea popolare (lo si deduce anche da altri testi: Plutarco, Vita di Dione, 28; Vita di Timoleonte, 54; 38). La presenza nello stesso luogo del più antico teatro risulta da un passo ancora di Plutarco (Vita di Timoleonte, 38), secondo il quale Timoleonte si recava in carro al teatro dopo aver attraversato l’agorà (provenendo evidentemente da Ortigia), strada obbligata per recarsiverso la Neapolis; inoltre, dal passo di Diodoro che ricorda tra i monumenti costruiti da Ierone II il grande altare «prossimo al teatro»: quest’ultimo non è citato tra le opere di Ierone II, ed era dunque preesistente.
In questo più antico teatro dobbiamo collocare alcune celebri rappresentazioni, come la prima delle Etnee di Eschilo, la tragedia composta per Ierone dopo la fondazione della nuova colonia di Etna al posto di Catania nel 476 a. C. Anche i Persiani sarebbero stati rappresentati per la prima volta a Siracusa, secondo Eratostene (Schol. ad Aristoph., Ranae 1028).
La parte conservata_del teatro si riduce quasi esclusivamente al settore scavato nella roccia, mentre del tutto scomparsa è la parte alta della cave,e così pure l’edificio scenico, realizzati in blocchi di pietra,che furono asportati per essere utilizzati nelle grandi fortificazioni, di Ortigia dell’epoca di Carlo V (tra il 1520 e il 1551). Gravi danni furono arrecati anche dai mulini installati nel monumento nel corso delXVI secolo. Vari scavi sono stati realizzati tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento, nel 1921, ira il 1950 e il 1954, e ancora nel corso degli anni ’60. La lacunosità dei resti conservati, e l’estrema complessità dei problemi che essi pongono agli studiosi, rendono assai ardua la ricostruzione delle varie fasi del. monumento, in particolare per quanto riguarda l’edificio scenico, del quale sono visibili solo le tracce in negativo, tagliate nella roccia.La cavea ha il diametro di 158,60 m, ed è quindi una delle più ampie del mondo greco. Essa comprendeva in origine 67 ordini di gradini, divisi in nove cunei da otto scalette, ed era suddivisa in due settori da una precinzione (diazoma), che correva all’incirca a metà altezza. Questa costituiva l’accesso più importante alla stimma cavea, e ancora oggi vi si perviene direttamente dall’ingresso, attraverso una strada tagliata nella roccia. La parete a monte del diazoma è ornata da modanature in alto e in basso. Su di essa sono incise, in alto, in corrispondenza di ognuno dei cunei, iscrizioni in grandi lettere greche. Il cuneo centrale (V) reca il nome di Zeus Olimpio; il secondo a destra quello di Eracle; gli altri di questo lato, perduti, dovevano recare il nome di altre divinità (si è pensato a Demetra). Sul lato opposto, a ovest, si trovano i nomi di Ierone II (IV), di sua moglie Filistide (III), e di Nereide, la figlia di Pirro e nuora di Ierone (II). In corrispondenza del I cuneo era forse il nome di Gelone II, figlio di Ierone, e a lui premorto. L’iscrizione del nome di alcune divinità nel settore est e di alcuni membri della famiglia reale in quello ovest serviva certamente per facilitare L’accesso degli spettatori ai loro posti. Essa, comunque, permette di datare con notevole precisione la realizzazione del teatro nelle sue forme attuali: tra il 258 (data del matrimonio di Gelone II con Nereide) e il 215 (morte di Ierone). È infatti escluso che le iscrizioni siano state aggiunte in un secondo momento, e lo scavo in profondità dell’immensa cavea avrebbe comunque obliterato ogni traccia di un più antico edifìcio.
La parte costruita della cavea iniziava a partire dal XIX gradino al di sopra del diazoma, ed era sostenuta da un muro esterno (analemma), che toccava il punto più alto a sud-est (8,92 m) e sosteneva il terrapieno artificiale su cui poggiava la parte alta della cavea, ora scomparsa. Sembra che in una prima fase il teatro fosse privo di pàrodoi, e che l’accesso all’orchestra avvenisse tramite due passaggi ai lati della scena. Successivamente furono create delle pàrodoi, ritagliando i muri frontali dell’analemma, che da allora vennero a essere paralleli alla scena (mentre in origine erano inclinati, come spesso avviene nei teatri greci).
L’orchestra, nella fase più antica, era delimitata da un canale scoperto (euripò) largo 1,05 m, oltre il quale una fascia di 2,95 m era destinata al pubblico. In un secondo tempo tale canale fu interrato, e sostituito da un altro prossimo alle gradinate, assai più stretto (0,34 m): il diametro dell’orchestra passò così da 16 a 21,40 m.
Oltre lo spazio semicircolare dell’orchestra era la scena, le cui strutture sono quasi completamente scomparse. Restano solo numerose cavità e fori tagliati nella roccia, corrispondenti a varie fasi dell’edifìcio scenico, che formano una sorta di palinsesto, di difìicilissima lettura. Secondo alcuni studiosi anche la scena, come la cavea, non è anteriore a Ierone II. Non si può escludere del tutto, però, che nello stesso luogo fosse anche la scena del più antico teatro, che quasi certamente occupava la medesima posizione dell’attuale.
Il Rizzo propose di riconoscere in cinque spianamenti, della roccia (65 e 66 nel senso est-ovest; 60, 62, 63 in senso nord-sud) la preparazione di una grande scena munita di paraskénia, da lui datata tra il V e il IV secolo. In realtà, due dei grandi spianamenti nord-sud (62 e 63) non sono altro che i passaggi (pàrodoì) originali che davano accesso all’orchestra, mentre gli altri sono piuttosto da riferire alla preparazione della scena di età romana (che però, molto probabilmente, sostituiva, nella stessa posizione, una più antica scena ellenistica). A questa appartenevano probabilmente il lungo canale scavato nella roccia e coperto (31,33), al quale si accedeva da una scaletta sottostante al palcoscenico (32), e che attraversava l’orchestra da sud a nord, fino a raggiungere una stanzetta quadrata . Si è proposto di riconoscere in tale apprestamento le « scale carontee », per mezzo delle quali si potevano avere particolari effetti scenici (scomparsa o apparizione improvvisa di. attori, ecc). Entro questa fossa fu scoperta la cariatide che decorava la scena ellenistica (ora al Museo di Siracusa). Alle fasi più antiche della scena appartengono anche la fossa 47, che presenta a sud lunghe incisioni verticali a coda di rondine (si è pensato che fosse utilizzata per il sipario, come le più tarde fosse antistanti, di età romana), una serie di incassi perpendicolari, a nord della fossa stessa (81, 82), e una lunga crepidine con le tracce di una serie di colonne e di pilastri, che vi poggiano sopra (92). Questa costruzione viene in genere interpretata, insieme alle fosse retrostanti, come una piccola scena mobile, destinata alle rappresentazioni fliaciche (una sorta di scenette clownesche tipicamente italiote). Potrebbe però trattarsi anche di un elemento avanzato della scena ellenistica più antica.Sui lati di questa sono due grandi piloni risparmiati nella roccia (lunghi più di 14 m), determinati dal taglio delle párodoi a L, e inclusi nella scena d’età romana. Di questa rimangono: gli spianamenti della roccia che, per le loro dimensioni (circa 3 metri di larghezza) mostrano di aver sostenuto strutture imponenti a più piani; la fossa dell’aulaeum (sipario) (27), con una serie di fori destinati a contenere le strutture telescopiche che ne permettevano l’innalzamento, e la camera di manovra circolare a est; due incassi semicircolari negli spigoli interni dei piloni di roccia laterali, sui quali si legge anche la traccia del proscenio. Queste cavità appartenevano evidentemente a due nicchie semicircolari, entro le quali dovevano aprirsi le porte laterali dell’edificio scenico. Quella centrale, più ampia, era probabilmente al centro di una nicchia di forma rettangolare: è questo uno schema che non appare mai nei teatri auguste! e successivi, che presentano in genere una nicchia semicircolare al centro, e due rettangolari ai lati (a partire dal Teatro di Marcello). Esso si ritrova, invece, nel teatro di Pompeo: sembra quindi probabile che la sua presenza nel teatro di Siracusa sia da ricondurre a età augustea piuttosto antica, e cioè al momento stesso della deduzione della colonia.
In età tardoimperiale la situazione fu totalmente modificata, probabilmente per adattare l’orchestra agli spettacoli dei giochi d’acqua (colymbetra). Vi fu allora realizzata quella fossa di pianta trapezoidale (40), che è stata a torto interpretata come traccia superstite di un teatro arcaico. In tale occasione si dovette arretrare la scena, e quindi anche scavare un’altra fossa per l’aulaeum, che è più lunga della precedente, e presenta anch’essa una camera di manovra a est (14). Non è sostenibile, invece, che il teatro sia stato trasformato per i giochi gladiatori, come pure è stato proposto: manca infatti del tutto la caratteristica più tipica che ritorna in questi casi, e cioè l’eliminazione dei gradini più bassi della cavea per la creazione di un alto parapetto (ad esempio nei teatri di Taormina e di Tindari). La presenza di una griglia metallica, di cui restano le tracce, sarebbe stata comunque insufficiente allo scopo protettivo. Del resto, l’ipotesi era basata sostanzialmente sulla datazione tarda (età severiana, o successiva) dell’anfiteatro. La sicura cronologia augustea di questo rende insostenibile l’utilizzazione del teatro per i giochi gladiatori.
Un’iscrizione, ora perduta, permette di datare con precisione i lavori dell’ultima fase (CIL, X 7124). Vi troviamo menzionato un Nerazio Palmato, probabile governatore (consularis) di Sicilia, come autore di un rifacimento del teatro che comprendeva in particolare la scena. È probabile che si tratti dello stesso personaggio che restaurò la curia di Roma dopo il sacco di Alarico {CIL, VI 57128): in tal caso, i lavori dell’ultima fase del teatro di Siracusa saranno da attribuire addirittura ai primi anni del v sec. d. C.La cavea del teatro è dominata da una terrazza, tagliata nella roccia del sovrastante colle Temenite. A questo si accedeva tramite una scalinata al centro, e una strada incassata sulla sinistra (a ovest), nota come via dei Sepolcri. Lo spianamento artificiale era occupato da un grande portico a L, che includeva la metà occidentale della cavea. Di questo portico è oggi visibile solo una banchina tagliata nella roccia, a 7,40 m dalle pareti di fondo, che costituiva la fondazione del colonnato frontale. Restano anche tratti della pavimentazione in cocciopesto, e fori per le travi del tetto nel tratto di parete rocciosa conservato per una notevole altezza (fino a 8,56 m) sul lato nord. In fondo al portico era anche una banchina, alta e larga 0,45 m, conservata in alcuni tratti all’estremità ovest del portico settentrionale.
-

IL TEMPIO DI ATHENA
Sia la pianta che l’ alzato erano di tipo canonico, con la contrazione degli ultimi intercolunni laterali. Le colonne avevano un leggero rigonfiamento nella parte centrale (entasis) e 20 scanalature, mentre gli echini dei capitelli erano leggermente schiacciati (quest’ultimo è un elemento che permette di datare gli anni della costruzione). La cella, libera da sostegni intemi, si concludeva con l’opistodomo, un ambiente posteriore alla cella. — I gocciolatoi, da cui defluiva l’acqua piovana, avevano la forma di protomi leonine (decorazione a forma di testa di animale), valorizzando la plastica ferocia, mentre lo scudo dorato del frontone est (via Roma) rappresentava il punto di riferimento per i marinai che arrivavano o partivano da Siracusa.
Prospetto del tempio di Athena
Il complesso sacrale più importante dell’isola è quello che sorgeva proprio al centro di Ortigia, nel, punto più, elevato, dove il Duomo ne ha conservato in parte i resti. È da sempre visibile, inglobato nelle strutture della chiesa il grande tempio, dorico identificato con l’Athenaion. Scavi effettuati tra l’inizio del secolo e anni recenti nei paraggi del Duomo, del retrostante Arcivescovado, e sotto il vicino Palazzo Vermexio, sede del Municipio, rendono oggi possibile una conoscenza sufficientemente dettagliata dell’area sacra e delle sue fasi. Fin dall’inizio dell’insediamento greco una parte di questa area sembra essere stata riservata a scopi di culto.
Il primo edifìcio monumentale, un” tempio arcaico di stile dorico, databile nei decenni centrali del VI sec. a. C., occupò la stessa area del periptero classico ancora conservato. Se ne raccolsero alcune parti negli scavi effettuati tra il 1912 e il 1917: elementi architettonici, terrecotte, e una parte dell’altare.
Poco dopo l’inizio del V secolo, come si deduce dai dati stratigrafici quest’edifìcio fu demolito e sostituito con il tempio attuale, che si può attribuire con certezza al periodo dei Dinomenidi, e più probabilmente al primo di essi, Gelone.
Molte caratteristiche architettoniche e decorative accomunano l’edificio al tempio della Vittoria di Himera.
E’ dunque probabile che i due templi siano stati costruiti contemporaneamente, e per la stessa occasione, da identificare con la stessa vittoria di Himera sui Cartaginesi, che tanta gloria e tante ricchezze procurò a Siracusa (un caso parallelo e quello di Agrigento) L’edificio andrà dunque datato tra il 480 e il470 a. C.
La sua identificazione con il tempio di Atena è basata sul passo di Cicerone, che lo ricorda come uno dei due più importanti edifici templari di Ortigia, insieme a quello dedicato ad Artemide; inoltre è significativo un passo di Ateneo (XI 462), secondo il quale lo scudo dorato collocato nel frontone del tempio di Atena era l’ultima cosa che si vedeva dal mare,allontanandosi da Siracusa: in effetti, ciò si addice mirabilmente alla posizione del tempio incluso nella Cattedrale, che è situato nel punto più alto dell’isola. Di questo tempio,parla lungamente Cicerone (Verrine, II 4, 124-5) esso infatti fu radicalmente saccheggiato da Verre, che tolse le decorazioni in avorio e le borchie d’oro che ornavano i battenti della porta, e’ soprattutto le serie di tavole dipinte che. ricoprivano i muri della cella, raffiguranti un_ combattimento, di cavalleria di Agatocle, probabilmente contro i Cartaginesi, e 27 ritratti di tiranni e re di Sicilia.
È probabile che il grandioso, complesso figurativo fosse stato collocato nel tempio proprio per, ricollegare le imprese di Agatocle contro i Cartaginesi a Gelone, e alla battaglia di Himera, per la quale il tempio era stato costruito.
La galleria di ritratti veniva, a formare, in un certo modo, una serie di « antenati ideali » per un personaggio di umili natali come Agatocle che non poteva vantarsi di alcun’altra prosapia.La scelta del tempio di Atena fu certamente determinata anche da altre considerazioni: la dea, protettrice delle arti e degli artigiani doveva essere particolarmente cara ad Agatocle, che in gioventù aveva esercitato il mestiere di vasaio. Sappiamo che nel corso della prima grande battaglia vinta contro i Cartaginesi in Africa (probabilmente rappresentata nel grande quadro esposto nel tempio, che doveva costituire una sorta di enorme ex-voto) il favore della dea si manifestò con il calare sull’esercito siracusano di alcune civette, uccello sacro ad Atena (Diodoro, XX 11, 3-4). L’utilizzazione del tempio quasi come santuario dinastico (da parte di Agatocle, ma forse anche di Gelone) rende probabile la sua collocazione nei pressi del palazzo di Ortigia, che infatti era negli immediati paraggi dell’odierna Cattedrale: ciò che costituisce un’ulteriore conferma nell’identificazione del tempio con quello di Atena.
Il tempio è contenuto, come s’è detto, nelle strutture della chiesa, che fu ricavata in esso fin dalla sua prima fase, del VII secolo (dopo una fase di trasformazione in moschea, fu riconsacrata al culto cristiano nel 1095) : l’eliminazione di gran parte dei rifacimenti barocchi, e la liberazione delle strutture greche, quali oggi si possono vedere, è del 1925. Per la costruzione della chiesa si è utilizzato un procedimento semplicissimo, che si riscontra anche in casi analoghi (come il tempio detto « della Concordia » ad Agrigento): l’edifìcio centrale (sekós) venne trasformato nella navata centrale, ritagliando arcate nei suoi muri laterali, mentre le navate laterali risultarono dallo spazio compreso tra questi e i colonnati, i cui intercolumni furono chiusi. Per unifìcare lo spazio interno , si dovettero naturalmente, demolire i tramezzi tra la cella,il pronao e l’opistodomo. Inoltre, l’orientamento fu rovesciato, per la necessità di orientare ad est il coro della chiesa che occupa il posto della facciata del tempio.
Si tratta di un. grande, periptero. dorico (22×55 m), con 6 colonne sui lati corti e 14 sui lati lunghi, costruito in calcare locale ma con la sima e le tegole esterne in marmo ,delle Cicladi. Le colonne presentano un diametro inferiore di 1,92 m, e un’altezza di 8,71, con un rapporto di 4,53, leggermente inferiore a quello del contemporaneo tempio di Zeus a Olimpia. L’aspetto dell’edificio è ormai del tutto canonico, sia nella pianta (con opistodomo al posto dell’arcaico àdyton e lati esterni del sekós coincidenti con due colonne della fronte) che nell’alzato. In particolare, era risolto il conflitto angolare, con la contrazione dei due ultimi intercolumni laterali. Le colonne presentano ancora una leggera éntasi (rigonfiamento) e 20 scanalature, mentre gli echini dei capitelli sono ancora leggermente schiacciati: tutte caratteristiche che convengono perfettamente a una datazione intorno al 480-470 a. C.