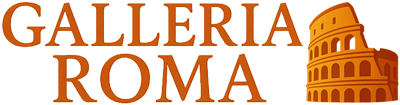Questa raccolta vuole ricordare tutte le persone che hanno contribuito con i loro studi e le loro opere a dare lustro alla nostra città.
Siano stati loro figli naturali o adottivi di Siracusa, ad essa si sono sentiti di appartenere maturando nel tempo un legame culturale, artistico, sociale; un amore spirituale ma anche fortemente terreno per questa città che da ogni sua piega fa trasparire secoli di storia e di storie lasciateci da altri viaggiatori che in ogni tempo hanno deciso di interrompere qui il il loro viaggio, incantati da una natura fatta di luce, profumi, sapori.
Donne e uomini che hanno amato Siracusa alla quale hanno dedicato, hanno donato, per la quale hanno scritto, hanno creato, hanno lavorato.
Sono diventati personaggi per un intervallo di tempo, breve, lungo, e dopo sono stati dimenticati perché è così che accade col passare del tempo.
Categoria: Lifestyle
-

Siracusani famosi
-

TERZI ANDREA
Di povera famiglia, fu aiutato da uno zio canonico e poté recarsi a Palermo, dove, sotto, la guida del Patania, si dedicò specialmente all’acquarello. Incitato dall’abate Gravina, a soli diciannove anni copiò quasi tutti i quadri del tempio di Monreale; e i suoi disegni servirono poi ad illustrare la “storia” della detta chiesa, esordì nel 1861 con l’opera Il Duomo di Monreale Copiò pure i quadri della cappella Palatina, illustrò l’opera La cappella Palatina: opera che fu premiata all’Esposizione Universale di Vienna nel 1873 e a quella di Parigi nel 1878. Una ammirata Pianta topografica ed archeologica di Siracusa, in quindici tavole, gli fu commessa dal Ministero della Pubblica Istruzione. Espose a tutte le mostre italiane; e frequentemente all’estero, specialmente a Vienna e Parigi.
-

RIZZO PIPPO
Corleone (PA) 1897-Palermo 1964
Diplomatosi all’accademia di Salerno aderì al Futurismo. In seguito si orientò verso un corposo realismo sui soggetti popolareschi siciliani. I suoi lavori sono apparsi alle Biennali Veneziane: nel 1926, Lampi e Futurismo e Fascismo; nel 1927 è presente alla Promotrice di Torino; nel 1928, Foot-ball; nel 1930, Anno VIII; Lavoro dei campi; La battitura del grano; Verso sera; Campagna; Donna con chitarra; Figura alla finestra; Autoritratto. Nel 1927 Fututrismo e Fascismo fu riesposto alla Quadriennale torinese. Insegnò all’Accademia di Palermo titolare di una pittura ed inoltre fu dell’Accademia direttore. Diresse la scuola libera di Nudo dell’Accademia di Roma.
Dal sito www.corleoneworld.it riportiamo :
Pippo Rizzo è nato a Corleone il 6 gennaio 1897, da famiglia di artisti: la madre, infatti, era cugina di Domenico Trentacoste,scultore già famoso.
Rizzo studiò all’istituto di Belle Arti di Palermo ed espose per la prima
volta le sue opere pittoriche nel 1916 al Kursal Biondo durante una Mostra Pro Potrici Ars.
Cinque anni dopo, durante un soggiorno a Roma fu affascinato dal movimento Futurista e tornato a Corleone fondò il circolo culturale “Rinnovamento”.
Dopo varie mostre a Palermo dove espose alcuni manufatti e arredi futuristi ebbe la sua grande occasione quando il suo quadro “i Lampi” fu esposto alla Biennale di Venezia nel 1926.
Tra i suoi allievi ricordiamo soprattutto Renato Guttuso che debuttò in una Mostra organizzata a Palermo nell’aprile dei 1929.
Rizzo muore il 4 marzo dei 1964 dopo aver diretto l’accademia di Belle Arti di Palermo prima e di Roma poi. La città di Corleone nel 1992 gli ha dedicato il Museo Civico.Dal sito www.icvasicorleone.it riportiamo parzialmente :
“Alle ore 02.15 del 6 Gennaio 1897 a Corleone nasce Pippo Rizzo,da Don Nino,originario di Capaci,che a Corleone aveva aperto il ristorante “Stella d’Italia” in Piazza Nascè ,e da Rosa Trentacoste, originariadi Marineo e cugina dello scultore Domenico Trentacoste(Palermo,20/9/1859 – Roma,18/3/1933) .
Ultimo di 5 figli,da bambino scarabocchiava col carbone su qualsiasi cosa,ma la sua passione era il gesso che riusciva a recuperare per strada seguendo i “scecchi d’issara” . Don Nino aveva stabilito che il figliodoveva diventare ingegnere. Ma un giorno si trova ad entrare nel ristorante un ingegnere di nome Torregrossa…….E’ stato lui a convincere Don Nino ad iscrivere Pippo all’Accademia BB.AA. .
Pippo aveva 4 fratelli : il primo Nenè era andato in America,Fara si era fatta suora, Antonietta si era sposata,l’ultimo,Nicola,era entrato in un convento francescano a Palermo………Fu proprio la vocazione
del fratello a risolevere i problemi per mandare Pippo all’Accademia BB.AA.
Pippo se ne andò a vivere in convento,che era vicino all’Accademia, sotto la protezione del fratello, Fra’ Tommaso . Qui trovò anche l’amore: Pippo spesso se ne andava a dipingere in terrazza ed un giorno,affacciata ad una finestra di una casa vicina,vide una ragazza bionda .Quella ragazza, il cui nome era Maria Carramausa, il 5 Dicembre 1924,divenne sua moglie,nonostante i genitori di lei avessero in ogni modo ostacolato quell’unione, convinti che un pittore squattrinato e che andava in giro con un cravattone rosso non prometteva niente di buono per la figlia. Dalla loro unione nacquero 2 figlie, Elica ed Alba. Nel 1918 fondò con alcuni amici a Corleone un circolo culturale “Rinnovamento” che suscitò l’attenzione del futurista F.T Marinetti………Nella sua abitazione realizzò una casa d’arte dove anche la moglie collaborò a realizzare tovaglie,tovagliolette,scialli su disegni del marito. Espose per la prima volta nel Maggio 1916 al Kursaal Biondo di Palermo, in occasione della mostra “Pro Patria Ars”……
Nel 1936 venne nominato Direttore dell’Accademia BB.AA. di Palermo. Nel 1939 si trasferisce a Roma, poi torna a Palermo nella casa della moglie, in Via Serradifalco 78, riprende il suo posto di Direttore dell’Accademia BB.AA. di Palermo ………………Spesso soffriva di crisi cardiache e ogni volta la moglie interveniva con un’iniezione fino al 5 Marzo 1966 quando nessun intervento fu possibile, nessuna proroga gli fu concessa, come lui stesso diceva . Pippo aveva 67 anni ” .
E’ stato Maestro del pittore bagherese Renato Guttuso . -

Ova, ’na fimmina e ’na jaddina fanu ’n mircatu
Nella società contadina, una delle incombenze quotidiane delle donne era quella di occuparsi (in dialetto cuvirnari) delle galline per contribuire con la vendita delle uova al bilancio familiare e alla preparazione del corredo per le figlie. I maschi erano impegnati dall’alba alla sera tardi nel faticoso lavoro dei campi.
Haju puddasceddi (pollastre) ténniri, ténniri, ova frischi e bielli! era la banniata (Dal germanico BANDUJAN = dare pubblico annuncio) di quelle massaie che si recavano in città o nei paesi vicini per vendere uova o qualche pollastra. Il modo di dire Ova,’na fimmina e ’na jaddina fanu ’n mircatu, nato a proposito, con il tempo ha acquisito il significato metaforico di “Basta poco per fare chiasso e confusione”.
Questo tipo di allevamento domestico per la donna non era un lavoro pesante in quanto le galline erano in grado di procurarsi da sole il nutrimento razzolando per la campagna e attorno al casolare, da qui il detto: ’A jaddina ca camìna s’arricogghi câ vozza (gozzo) china. (In senso figurato: “Chi vuol guadagnare esca fuori, si muova”). Tutto al più poteva preparare loro, e quando ne aveva la possibilità, un pastone di crusca: Dici la jaddina a la patruna: Dammi di lu pizziddu (diminuitivo di PIZZU = punta e quindi piccolo becco) ca ti dugnu di lu culiddu (una variante è pirtusiddu; in senso figurato il motto significa: “Se vuoi un buon lavoro, paga bene” e ciò per evitare che il lavoro venga fatto a peri ’i jaddina, cioè male). Si credeva che impastando la crusca con foglie d’ortica, le galline producessero più uova.
C’era anche chi, per avere ogni giorno l’uviceddu friscu pô picciriddu, si permetteva di allevare (tinìri ’i jaddini) nel cortile del paese o della città due o tre galline rinchiuse dentro una nassa (gabbia in legno) o libere sul terrazzino di casa. Si riteneva che la loro presenza, così come quella dei gatti, non potesse arrecare alcun danno a cose e a persone: Jatti e jaddini ’u Signori si nni ridi!.
Cci-cci-cci…o Picci- picci- picci… era il verso per chiamarle al cibo (’a ’mpastata di canigghia), Sciò-sciò-sciò quello con cui si scacciavano.
Una credenza popolare giustificava così il coccodè della gallina: Nun mai ppi l’ovu la jaddina canta, ma pi lu sforzu lu culu cci abbampa (gli brucia, denominale di VAMPA = fiamma).
Per sapere quale delle galline nel corso della giornata avrebbe fatto l’uovo, la massaia introduceva il dito medio nell’orifizio anale di ogni bestiolina. Quella che per l’età smetteva di fare uova, detta jaddina stagghiata (Dal latino STAGNARE = essere fermo, cessare la propria attività), veniva venduta o, in occasione di festività importanti come il Natale e la Pasqua, finiva sulla tavola dei padroni perché ’A jaddina vecchia fa broru bonu, su quella del povero ci finiva raramente: Si ’u poviru si mancia ’a jaddina o è malatu iddu o è malata ’a jaddina.
Gli introiti derivanti dalla vendita delle uova erano spesso indispensabili per la vita di una famiglia per cui, quando erano in tante le galline che non producevano uova perché entrate nel ciclico periodo dell’estro, la massaia le immergeva fino al collo nell’acqua fredda per spegnerne il calore e far sì che riprendessero a fare uova.
Per rinnovare ’u jaddinaru (il pollaio) e potere vendere ’i jadduzzi (i galletti), la buona massaia vigilava sulla chiocciata. Qualcuna in controluce riusciva a distinguere le uova fecondate. Periodo favorevole alla covata era quello in cui la luna era crescente o piena; pare che fossero pochi i pulcini che, nati durante la luna calante, riuscissero a sopravvivere.
Scrive Pisano Baudo in Sortino e Dintorni : “…se i pulcini vedranno la luce nel mancamento della luna o morranno o cresceranno stentatamente –vengono allunati-… Quando si vede un bambino magro e rachitico si dice: Pari lu puddicinu di la luna. Per tre volte a luna nuova strappano le penne più lunghe della coda alle pollastre, dicendo: Crisci e ‘ngrassa, preia ’a morti ca ti lassa”.
Se veniva a mancare ’a çiocca (la chioccia) la massaia si dava da fare con un espediente ereditato dalla tradizione popolare. Alle ore 12 del 25 marzo, giorno in cui si ricorda l’apparizione dell’Angelo a Maria e l’annuncio dell’incarnazione, prendeva ’na jaddina niura (non aveva importanza se faceva ancora le uova) e la posava su una cesta dentro la quale aveva precedentemente messo, in numero dispari, le uova da covare. Per evitare che scappasse, con entrambe le mani la bloccava sulla cesta e quando la gallina non si muoveva più la copriva con un panno facendovi con la mano destra il segno della croce. Da quel momento la gallina sarebbe diventata chioccia (acciuccata) perché quell’ora di quel giorno, secondo la fantasia della popolazione rurale dell’Ottocento, era miracolosa per la fecondazione. Non per niente la Santa protettrice dei polli era la Madonna.
Se durante la covata, che durava dai 20 ai 25 giorni, scoppiava un temporale non c’era da preoccuparsi per la sana formazione dei pulcini perché la massaia aveva messo precedentemente sotto la paglia, che fungeva da letto alle uova, un pezzo di ferro in grado di assorbire le scosse dei tuoni.
L’attitudine propria delle galline nere, divenute chiocce in modo forzato, a non proteggere adeguatamente i propri pulcini nei loro percorsi giornalieri alla ricerca di cibo ha dato origine al detto Essiri figghiu râ jaddina niura con cui in senso figurato ancora oggi si suole indicare chi, all’interno della famiglia o di una comunità è meno rispettato degli altri, diversamente dal prediletto o beniamino che è indicato come Figghiu râ jaddina janca. Un’amara considerazione alla disparità di trattamento di qualcuno nei confronti di una persona piuttosto che di un’altra è l’espressione sentenziosa che si riallaccia al mondo di questi animali: Cci dissi ’u puddicinu ’nta la nassa: quannu maggiuri c’è, minuri cessa.
La chioccia naturale invece era più amorevole e protettiva, addirittura salvaguardava i propri pulcini ancor prima che venissero fuori dal guscio delle uova: ’A çiocca sapi scarpisari (calpestare) l’ova, un motto che in senso figurato oggi significa: “Chi è dell’arte sa ciò che fa”.
La gallina nera, se cantava spesso e bene, era considerata genio tutelare della casa, specie della padrona di casa dalla quale secondo un’antica filastrocca doveva essere mangiata:
La jaddina cantatura
nè si vinni, né si duna
si la mancia la patruna.
Altri geni tutelari della casa, detti mira, erano le testuggini, i ramarri e le lucertole. Essi non si dovevano uccidere, ma rispettare e nutrire. Maltrattamenti ad uno di questi animali, seconda la fantasia popolare, avrebbero comportato lunghe e penose malattie in famiglia.
Una volta che tutte le uova della covata si dischiudevano e venivano fuori i pulcini, la massaia difficilmente si illudeva di poterli convertire tutti in denaro, il proverbio Cu’ cunta puddicini cunta pirita la riportava alla realtà. Sapeva bene che quei pulcini prima che fossero cresciuti e diventati galli o galline ci sarebbe voluto del tempo e molti di loro sarebbero morti.
Solo da adulti e, a seconda del sesso, i pulcini si differenziano. Le galline, rispetto ai galli, mettono un piumaggio dalle tinte meno vivaci, creste più piccole e floscie e penne timoniere più corte. Inoltre sviluppano istinti materni e non battaglieri come quelli dei galli.
La sete del guadagno rendeva però impazienti quelle massaie che non erano disposte ad aspettare. Per sapere subito quanti dei loro pulcini sarebbero diventati galli e quanti galline, usavano uno stratagemma: li mettevano uno alla volta sul palmo della mano e nel tirare loro una delle incipienti penne della coda, recitavano questa formula:
Si si’ jadduzzu canta, canta
si si’ puddascia muzzicati l’anca.
Secondo la tradizione popolare, il pulcino che emetteva un pigolio era un potenziale galletto, quello che si pizzicava la parte posteriore era una pollastra.
Una volta diventati adulti, occorreva scegliere tra i sopravvissuti il nuovo leader del pollaio, ’u rre rô jaddinaru, il gallo da tenere, uno solo perché Dui jaddi ’nta gnaddinaru ’n ponu stari. Il prescelto doveva possedere più degli altri alcuni requisiti che gli avrebbero permesso di espletare la sua funzione di jaddu:
-doveva dimostrare di sapere guidare ’i jaddineddi alla ricerca del cibo secondo il detto: ’U
jaddu a purtari e ’a jaddina a scaliari (razzolare, frugare per trovare il cibo);
-doveva cantare puntualmente di mattino presto perché ’U jaddu è lu raloggiu di la campagna
anche se un antico detto recitava il contrario Cô jaddu e senza jaddu, Diu fa jornu (in senso
figurato: “Quando qualcosa deve accadere, non c’è scampo, nessuno è indispensabile”;
-doveva essere autoritario e dominare con la sua presenza tutto il pollaio: Tinta ’dda casa unni ’a
jaddina canta e ’u jaddu taci. (In senso figurato: “È da compiangere quella famiglia in cui il
marito è comandato dalla moglie”). Di eguale significato è l’altro proverbio: Si ridussi lu jaddu
di Sciacca d’essiri pizzuliatu di la çiocca che equivaleva A la casa ca ‘n c’è birritta (in senso
figurato, l’uomo) nudda cosa ci va dritta;
-non doveva brontolare senza motivo: ’A jaddina fa l’ovu e ô jaddu cci abbrusca ’u culu.
Per farli ingrassare meglio e alla svelta, gli altri galletti venivano capponati e venduti. Con la castrazione perdevano la voce e veniva loro tagliata ’a cicca o cricca (la cresta, la prima dal latino CIRCULUS , perché rotonda, la seconda dal greco CRICOS, perchè rotonda come un anello): Lu jaddu senza cicca è un gran capuni (e l’omu senza dinari è un gran minchiuni).
Le creste di quelli castrati, dopo essere state recise ed essiccate al sole e al vento, venivano passate sulle gengive dei neonati perché, secondo la medicina popolare, favorivano la crescita dei denti in maniera indolore. Si credeva anche che le uova calde e appena deposte, se strofinate sugli occhi, acuissero la vista.
A proposito di canto dei galli, mi si consenta una digressione. Sino ai primi del ’900, durante il giovedì grasso nella piazza principale di Rosolini, si teneva una gara tra squadre diverse. Ognuna si presentava con un gallo infiocchettato con nastri di colori sgargianti. Vinceva quella il cui gallo cantava prima degli altri. Il proprietario del gallo vincitore veniva proclamato rre rê jaddi (re dei galli) e partecipava alla sfilata per le vie del paese con il gallo in braccio e con una penna del suo animale in testa. Per stimolarli al canto, durante la gara tra i galli concorrenti veniva messa una gallina la cui presenza poteva scatenare un vero e proprio combattimento di galli.
Nella società contadina il rapporto fimmina-jaddina era regolato più dalla superstizione che dalla ragione. Per evitare l’assalto della baddottula (donnola) che, aggirandosi per le campagne, faceva strage di galline, le donne ricorrevano ad atti rituali come il maritamentu di la baddottula la cui formula deprecatoria era molto conosciuta.
La massaia, appena scorgeva quell’animale pericoloso per le sue galline, gli puntava l’indice di entrambi le mani recitando questo scongiuro tramandatoci da Salvatore Salomone Marino:
Baddottula, Badduttulina,
nun tuccari ’a jaddina
Ca ju ti maritu quantu prima!
Si si’ fimmina, ti rugnu ‘u figghiu rô re;
si si’ màsculu ti rugnu ’a rigina.
Si racconta che la donnola, una volta “maritata”, si allontanava definitivamente da quelle galline per andare a “sfogare sui topi il suo istinto vorace”.
Se ad insidiare le galline erano volpi e martore le donne ricorrevano all’aiuto di persone che, secondo la fantasia popolare, erano dotate di facoltà paranormali: un Vinnirinu (uomo nato di venerdì) o un Settiminu (il settimo maschio di una famiglia) che rendevano inoffensivi gli animali pollicidi. Lo stesso Salomone Marino scrive che ’u Vinnirinu si slegava un laccio di cuoio di una delle sue scarpe, vi faceva tre nodi e, tenendolo ben steso tra l’indice e il pollice di tutte e due le mani, affatturava la volpe o la martora tramite la recita di questa formula che implorava l’intervento soprannaturale:
Cummari, ca tiniti li jaddini
Purtati lazzi, firruzzi e catini
Ppi ’ncatinari vurpi e marturini:
scànzami la çiocca e tutti’i puddicini,
in nomu di lu Patri, lu Figghiu e lu Spiritu Santu.
Concludiamo con due locuzioni proverbiali che confermano l’indole bonaria ed ironica dei nostri avi. Quando qualcuno chiedeva loro qualcosa che essi non erano in grado di dare o che ritenevano controproducente dare, invece di rispondere con un secco “no” o con un categorico “mai”, usavano delle perifrasi con le quali solo apparentemente davano l’impressione di lasciare uno spiraglio di concessione, in realtà rimandavano ad un tempo che, come le calende greche, non sarebbe mai arrivato: Sì, quannu fa l’ova ’u jaddu! oppure: Sì, quannu piscia ’a jaddina! -

Incorpora
Salvatore Incorpora,nato a Gioiosa Jonica(RC) nel 1920 , è linguaglossese d’adozione .
Si è diplomato al Liceo Artistico di Napoli ; durante l’ultima guerra mondiale ha lasciato terrecotte in Polonia(Duomo di Warthenau),in Germania ed in Grecia,dove nel 1942 ha esposto alla I Mostra degli Artisti Italiani al Museo nazionale di Atene .
Ha esordito in Sicilia vincendo il III Premio di scultura delle feste Autunnali(CT,’49).
Ulteriori mostre : Agosto Vibonese(Vibo Valentia,’53,’54),Mostra del Sindacato BB.AA. (CT,’53), XXI Promotrice d’arte (CT,’54),Mostra del fiore(ME,’54),VII Premio Suzzara (’54), Mostra Nazionale (S.Benedetto del Tronto,’55),Mostra Arti Plastiche(ME,’55),I Mostra d’Arte Sacra(CT,’55),Mostra d’arte contemp.nea(Linguaglossa,’55) .
Ha partecipato alla Biennale Intern.le(Ravenna,’73,’75,’77,’79,’81).
Sue opere, il Monumento ai Caduti in Piazza Botteghelle(Fiumefreddo di Sicilia) e la Via Crucis nella Chiesa Santissima Maria del Rosario del Quartiere Castello,sempre a Fiumefreddo .
Pannelli di bronzo sono visibili alla porta dell’edificio del Convento dei Domenicani a Linguaglossa(CT) , paese dello scultore Francesco Messina e cittadina a metà strada fra il mare di Taormina e la neve della Pineta .
E’ famoso per le terracotte dei suoi magici Presepi natalizi . Ha pubblicato : -Il Duomo di Linguaglossa . -S.Francesco di Paola a Linguaglossa . -Il settecentesco coro ligneo della Maggiore Chiesa di Linguaglossa .
L’artista Salvatore Incorpora,cittadino onorario di Linguaglossa, dove vive da oltre 50 anni, ha consegnato, anni addietro, all’Amministrazione Comunale una lettera con la quale dichiara di offrire al paese di Linguaglossa sue opere di scultura, pittura, disegni, presepi, alla sola condizione che vengano esposte permamentemente in una Pinacoteca da realizzarsi ! -

PIRRONE
Lo scultore, medaglista e caricaturista, Giuseppe Fortunato Pirrone, detto Peppino, e nato il 5 Novembre 1898 a Borgetto (PA) da un padre, Pietro, lavoratore agricolo, e da un’ orfanella, Elvira Emilia Pirrone Resso (1877 -1911): la data vera risale al 3 Novembre, ma forse, a causa delle celebrazioni dei defunti, fu ritardata l’ iscrizione all’anagrafe . Rimane a Borgetto fino all’età di 3 anni e mezzo; il padre, impiegato di Prefettura, e trasferito dapprima a Mazara del Vallo ( 1902 – 1903) e quindi ad Alcamo, dove frequenta le Scuole Elementari e la prima Tecnica .
Nell’Aprile 1910 il padre, per ragioni di lavoro, si trasferisce a Noto (Sr), città ingegnosa, di cui Peppino si innamora subito, dato il suo trasporto per le Arti . Nell’ Ottobre 1911, nel periodo della epidemia di spagnola, muore la madre Elvira ed il padre, nel 1912, sposa in seconde nozze una ragazza del luogo, da cui poi ha due figlie femmine ed un figlio maschio, di nome Gaspare. Appena quindicenne, modella un S. Corrado in creta e lo espone tra due steariche sul davanzale della finestra di casa, in Via Cavour, angolo Vico F. Tortora, in attesa del passaggio della Sacra Urna il 19 Febbraio 1913 ; inizia l’attività artistica a Noto, giardino di pietra, ha i suoi primi success! con 3 opere: Vera, Giacometta e Rina Corsi. Per il lungo soggiorno ( 1909 – 1929 ), soleva dichiararsi ” netino ” , però e vissuto, con studio in Via A. Guglielmotti N. 57, a Roma, dove e morto il 23 Febbraio 1978 alle ore 4, ad oltre 79 anni: riposa nella cappella eretta nel sito cimiteriale donatogli dal Comune di Recanati, insieme alla moglie, la pittrice netina Maria Mauceri ( Noto 7 Marzo 1905 – Roma 9 Settembre 1986 ), da cui però, per un fibroma uterino, non ha avuto figli; unica erede e una nipote, tale signora Zagarella da Pozzallo, figlia di una delle due sorelle .
Il ” greco ” Peppino Pirrone ha decantato come nessun marchigiano tutte le opere di G. Leopardi e la città di Macerata e di Recanati: un Crocifisso e collocate nella Chiesa Collegiata di S. Giovanni a Macerata ed un’ Obelisco Triangolare a Recanati (1973 ). Nell’ Aprile 1918 e chiamato alle armi, alla 39° Fanteria a Napoli; nel Febbraio 1919 e congedato ed ritorna a Noto: nel frattempo ha conseguito alle Scuole Normali di Noto (1918) il Diploma di Insegnante Elementare. In quel periodo conosce il pittore – decoratore Prof, Matteo Santocono, che non tarda ad avvedersi della natura poliedrica del suo ottimo allievo, e Lo segue nelle decorazioni dei soffitti .
Dall’ Ottobre 1922 fino al 1927, frequenta l’Accademia BB. AA. di Palermo : maestri per la scultura Antonio Ugo, di tendenze naturalistiche, e, per il disegno, Archimede Campini, che lo fa rimanere fedele al rigore stilistico del Rinascimento. Si diploma, gia sposato, nel 1928 air Accademia Reale di Napoli con 29 su 30, sotto la guida del Maestro Luigi De Luca, vincendo uno dei due premi della Fondazione Rossi ed un viaggio d’istruzione in Germania.Rientra a Noto, città barocca, insegna disegno all’Istituto Magistrate, ma dal giorno 8 Gennaio 1930 si dimette e si trasferisce a Roma, da dove inizia ad affermarsi come scultore ritraendo ministri e personalità e da dove non si muove più .
Nel 1948 conosce il marchigiano Guido Mestica di Apiro , Provveditore agli Studi di Roma, che istituisce il Centro di Educazione Artistica e Lo nomina uno dei dirigenti per per l’insegnamento della ceramica agli insegnanti fino al 1964, anno in cui va in pensione . Per due anni scolastici 1967 -1969 ha ricoperto la cattedra di scultura all’Accademia BB. AA. di Catania, fino al 70° anno di età ; altresì, aderente alla CISL – Artisti, ne è stato Segretario Nazionale dal 1964 al 1971. Amico fraterno dei pittori Ciccio Patanè, Pippo Civello, Lamberto Ciavatta e degli scultori Sgandurra, Assenza, Poidimani e Monica, del Prof. E. Papa, che ha curato nel 1970 una sua monografia d’arte, del poeta Giovanni Grasso, l’Ellenico Peppino Pirrone ha partecipato alla Quadriennale (Roma,’ 52,’ 56,’ 60,’ 64 ) ed alla XXIV, XXVII, XXVIII Biennale di Venezia, con mostra Personale nell’ultima, alle Mostre Internazionali di Scultura di Carrara e Trieste, a tutte le Mostre Europee della Medaglia (F.I.D.E.M.di Paris) dal 1953 al 1977 .
Il suo primo ritratto e il Ritratto di Socrate Ciccarelli ( Roma, 1932), poi la Tomba Landogna ( Noto, 1934), Ritratto di Ciccio Accardo ( Noto,1936), La sonnambula ( ‘ 37), Busto di bronzo di Mons. G. Blandini ( ’38) e di Mons. Calabretta ( ’75) per la Cattedrale di Noto, Ritratto di Salvo Monica ( ’76) e Medaglia per la Madonna della Scala (’76 ) .
Mostre Personali: Brigate Amici dell’ Arte ( Macerata, ’51,’52 ), Sale dell’ Accademia Nazionale di S. Luca ( Roma,’55), Sale dell’ Agostiniana (Roma,’66).
Artista della medaglia, vanta una vasta e qualificata produzione di medaglie, esposte alle mostre di Paris, Roma, Praga, Stoccarda, Atene, Madrid, Amburgo : memore della lezione dei coniatori siracusani Eumene, Euclida e Cimone, ha rinnovato i fasti rinascimentali del Pisanello, ha dedicato una serie di omaggi a Segni, Momigliano , Einstein, Berenson, Carrà, Hemingway, Morandi, Baudelaire, Paolo VI, Casorati, Gui, Verga, Pirandello, Ungaretti, Totò, Renoir, J. F.-Kennedy, Martelli, Tomasi di Lampedusa, Mangano, Quasimodo, De Chirico ed ad alcuni famosi personaggi netini, Vincenzo Littara, Rocco Pirri, Mariannina Coffa (la Saffo di Noto), Antonio Corsetto, Giovanni Marrasio, Giovanni Aurispa ed Ascenso Mauceri .
Nella sua proficua produzione un posto di primo piano occupa la figura femminile, Mia Nonna, Ritratto di Nicoletta, Tina Di Lorenzo (’34), Mia Madre (’36), Basiliola (’41), Idolo (’50), Eulalia (’60), Lucilla (’51), Susanna ed Eva (’51), Cleo (’63), Clara (’63), Medusa ( ’64). Ha conseguito il Premio Nazionale la Soffitta di Terni, col bronzo ” Eterno femminino ” ( 1950 ) e la medaglia d’oro per le sculture ceramicate alla Mostra del Mezzogiorno d’ltalia ( ’53 ), Premio Cicogna (’55 ), ha partecipato I mostra d’arte (Linguaglossa, 1956); l’Accademia Nazionale di San Luca gli ha conferito il Premio Einaudi 1955 per la scultura, Premio Citta di Noto (’67), Mostra 2° Acino d’ oro (Pachino, ’73 ), nel 1970 ha partecipato con Samonà e Gregotti ai progetti per il nuovo Centro di Ghibellina, e stato premiato alla I Biennale Dantesca (’73 ) .. Ha lavorato su ordinazione della Città del Vaticano ( Musei Vaticani – Sala Pinturicchio ) e del Governo Libico a Tripoli.
Dal 1959 e stato Segretario Generale del Sindacato Artisti Italiani; nel 1963 ha eseguito la porta del Battistero della Chiesa di San Giovanni in Campi Bisenzio (Firenze), sull’Autostrada del Sole ed inoltre un artistico altare maggiore nella Chiesa dei SS. Cosma e Damiano ad Alberobello ( Ba,’ 67), la monumentale statua della Madonna della Pace sul Monte Scalambra ( Frosinone,’ 76) e numerose opere d’arte sacra presso la Cattedrale ed il Seminario ad Acireale ( CT ) . Ha rifiutato ogni onorificenza, tranne quella che il 23 Dicembre 1976 il Papa Paolo VI Gli ha conferito:” Equitem commendatorem Sancti Gregorii Magni ” . Ha istituito 2 gallerie, una a Noto ( Donazione Pirrone, 1966), dedicata alla madre Elvira, ma stranamente denominata Galleria Teresa Pirrone, ed una a Recanati (’72) in omaggio a G. Leopardi, della cui poesia e stato sempre innamorato .
Per V. Marotta,” caratteristica della sua arte universale e la capacita di mediate ataviche risonanze mediterranee ed elleniche col più attuale travaglio della vita d’oggi ” e per Etna ” le sue qualità di scultore, riportate sulla medaglia, fanno di Lui uno dei migliori medaglisti contemporanei ” e Mandel scrive che ” l’arte di Pirrone e tutto spirito, di valore e sapere, che prorompe come una forza vitale…”. Per Jacono,” nella sua personalità si ritrovano tutte le più significative caratteristiche dell’animo della sua gente ” e Miele parla di “forza espressiva ” e Mattei Lo descrive ” piccolo e bruno, con i lineamenti del viso fortemente marcati, eppure soffusi di tenerezza dolce “, Per Papa, ” lo spirito ellenico gli e entrato prepotentemente nel sangue, e divenuto linfa vitale …. ” , secondo Saru e ” un artista attuale che non rifiuta l’avventura delle nuove espressioni artistiche ” e per Cossu ” i modi più appariscenti li riscontriamo nella scultura più che nella medaglia “.
Per Guastella è ” insigne scultore e medaglista di chiara fama ” e per Moroni ” predilige la scena sacra; questo senso devozionale si rivela nel rispetto di tutto l’uomo, concepito ognora come immagine di Dio “.
Secondo Bonifazi,” dire Pirrone scultore e dire Pirrone essenzialmente ritrattista; l’arte del ritrarto in lui e innata … ‘* e per Sgroi ” tratta con eguale perizia il bronzo, la ceramica, la medaglistica il basso e l’alto rilievo … “.
Per Catalano, e un ” carattere vivace, arguto, bonario, piacevolmente discorsivo, talvolta polemico ed impulsivo ” ed ancora per Mincio ” in tutta la sua scultura si respira un’aria ardente, si rientra in contatto con una razza di forti ” ed infine il sacerdote Bianchi scrive che ” Pirrone e tra i valori che oggi s’impongono, e s’imporrà domani e sempre, per propria virtù “.
Sue opere sono visibili nei Musei di Paris, Roma, Oslo, Copenaghen, Shelley, Wrocraw, Sheffield, Stoccolma, Madrid, Isola di Formosa, alla Galleria d’ arte sacra di Milano – Niguarda (Sala Pirrone ), Galleria Pro Civitate Christiana di Assisi, GAM di Roma, Santuario di Gaudalupe, New Columbus (Pensilvania) ed in America, alla Pinacoteca Zelantea di Acireale (CT), presso la Chiesa Madre di Borgetto (l’acquasantiera ) ed inoltre numerose opere della sua collezione privata di autori vari sono state lasciate in eredita al Comune di Noto, cosi come si rileva da Arte Contemporanea, Galleria Teresa Pirrone, edito negli anni Settanta da Gioacchino Santocono Russo .
A Noto sono fruibili le seguenti opere : Altare del S. Cuore in Cattedrale, Busto a C, Sgroi al Liceo Classico, Testa di C. Nicolaci, Principe di Villadorata, presso il Palazzo Villadorata, Testa di S. La Rosa, presso lo studio dell’avvocato E. La Rosa e decorazioni o pitture artigianali da lui eseguite in casa Accardo, Pema, Di Giovanni, Landogna, Cassone, Landolina, Di Lorenzo, Di Liberto, Principe di Villadorata, Can. C. Tafaro, barone Granieri, ex-Circolo dei Nobili, notaio Bonfanti, notaio Dejean e presso il Santuario di S. Corrado di fuori; numerose opere sono infine in possesso del figlioccio di cresima, il pasticciere netino, Corrado Costanzo, del tappezziere ‘ Nzino Ruscica, del Prof. Landogna, dell’ex giocatore della Netina, Nino Amante, del critico d’arte, Bigi.
E’ stato autore del San Corrado in preghiera posto nella grotta dei Pizzoni presso il Santuario della Valle dei Miracoli (’36), del portale di bronzo della Cattedrale, raffigurante episodi della vita di S. Corrado Confalonieri (’83), del bel medaglione di S. Corrado, che fa parte del medagliere nel museo di Noto, ricco di ben 700 pezzi, del bronzetto San Corrado Confalonieri nel museo di Noto, del bozzetto premiato per il monumento a San Corrado alle porte di Noto, del bel bronzo di S. Corrado, ora al Palazzo Vescovile, del bronzo di 120 x 70 per le due ante d’ un portone, in lodi di S. Corrado, ora nel museo di Noto; ai giardini pubblici e ben visibile la statua di Matteo Camilivari, così come nella parte sud-ovest si notano i 4 busti marmorei, raffiguranti Giovanni Aurispa, Rocco Pirri, Corrado Avolio e Giuseppe Cassone.
Il Comune di Noto sta allestendo entro il 2002 l’apertura del Museo Civico, intestate all’adorata mamma Elvira, presso il Monastero di S. Chiara in Corso V. Emanuele . Il nostro Peppino ” ha marciato solo ” ( Catalano), ma oltre a una tentata virata verso Botticelli, A. Wildt e Medardo Rosso, è piuttosto arduo trovare nei suoi lavori o meglio ” sogni d’arte ” reminiscenze altrui: tutta la sua instancabile e vulcanica attivita obbedisce alle sollecitazioni dell’anima, che, dopo assorte meditazioni, sa tradurre in termini plastici…
Peppino Pirrone è uno dei soli dodici artisti siracusani (i fratelli Assenza, i gemelli Brancato, Monica, Poidimani, Pulvirenti, Scirpa, Sgandurra, Trombadori, Volanti) ad aver partecipato alla Quadriennale di Roma. ”
Amo Noto perchè mi ha accolto fanciullo, mi ha educato e formato artisticamente. Noto per me è la mia patria. Infatti il trasporto che avevo per le Arti, l’ambiente netino lo ha elevato in modo incredibile per le sue stupende architetture e le splendide sculture ” ( G. Pirrone ). -

Biagio Brancato
Biagio Brancato è nato il 2 Gennaio 1921 a Comiso ( RG) «città in cui ha sempre vissuto e lavorato) tranne per la breve parentesi ( 1937 -1942 ) dei suoi studi all’ Istituto dì BB. AA. di Urbino, e quella relativa al servizio militare (1942 -1946)
Nel 1937, compiuti gli studi alla Scuola d’ Arte di Comiso, frequenta per qualche tempo I’atelier di S. Fiume e partecipa al concorso nazionale per I’assegnazione di una borsa di studio che gli consentirà di frequentare il corso quinquennale all’ Istituto BB. AA. dì Urbino per le tecniche incisorie e I’ illustrazione del libro.
Amico di Bufalino, Guccione, Fiume, Micieli, Dì Stefano, Gulino, Candiano e La Cognata, è stato per anni I’ artefice principale e I’ anima dell’ISA di Comiso, rinunciando, per amore verso la propria terra e verso i suoi allievi, ad una splendida carriera artistica ; a conferma della sua valenza resta la produzione pittorica che lo colloca fra i maggiori artisti siciliani di sempre. Dalla fine degli anni Quaranta e per tutti gli anni Cinquanta ha svolto un’ intensa attività incisoria che gli è valso il Premio a Mazara del Vallo ( ‘ 47 ), Acitrezza(‘ 51), Caltanissetta (’52).
Formatosì come incisore, sulla base di esperienze disegnative asciutte e plastiche insieme, ” le opere degli anni’ 40 – ‘ 50 risentivano dell’ altro versante dell’ Espressionismo tedesco e le sue xilografìe avevano il sapore aspro della povertà contadina, in immagini fatte di neri e di bianchi, in segni spezzati a dichiarare il dolore nel desiderio di partecipare P.Nifosi ) “. Dagli inizi degli anni Sessanta, con quasi totale impegno, Brancato ha diretto fino al 1979 l’ ISA di Comiso, cioè fino alla data del suo volontario collocamento a riposo.
Alla fine degli anni Sessanta e per un perìodo di circa due anni, sperimenta nuove tecniche pittoriche nell’ambito dell’ informale : mostra Personale alla galleria Ponte Uno ( Modica). Tra gli anni Settanta e Ottanta mostre Personali alla Galleria Ponte Due ed il Gabbiano ( Ragusa), Margutta ( Siracusa,’71), L’ Androne ( Scicli ), Cà Brera ( Pozzallo ) . Premio, ex equo con P. Guccione, per le Arti Figurative( Ispica, ‘ 85 ) e mostra al Centro Studi Polivalente ( Ispica, ‘ 87 ). Nella sua lunga attività artistica ha esposto alla Quadriennale di Roma, alle mostre d’ incisione di Zurigo, Lima, alla Mostra degli artisti siciliani, organizzata dalla Biennale di Venezia, al Museo d’arte moderna ( Salon d’ Hiver, Paris ), Calcografia Nazionale( Roma), Museo del libro ( Bruxelles ), Biennale d’ arte ( Gubbio), Concorso Ceramica ( Faenza), Galleria Roma ( Melegnano ), Premio Suzzara.
Ulteriori mostre Personali degne di menzione : Antologica alla Biblioteca Comunale ( Santa Croce Camerina, ‘ 90 ), Palazzo della Provincia ( RG,’91), Palazzo di Leva ( Modica, ‘ 92 ), Sala Esposizione ( Vittoria,’ 92 ), Chiesa S. Teresa ( Scicli,’92 ), Galleria Regina di Quadri ( Modica, ‘ 92,( 94, ‘ 96 ), Nuova Sala Esposizione ( Modica, ‘ 93 ), Mostra Naz. le di pittura ( Vercelli, Santhià,’95, ’98 ) .Premio Banca Sella ( Santhià,’ 95 ), Centro Studi Rossìtto ( RG,’ 95 ), Pro Loco( Comiso, ‘ 96 ), Rassegna Acquaforte ( Modica, ‘ 97 ), Caffè Letterario Brancati ( Scicli, ‘ 01 ).
Secondo Bufalino,” non è un caso che al colmo della sua maturità sia pervenuto ad un’ arte senza spasimo, dove par di sentire come una debole eco dei Maestri del postimpressionismo ( Bonnard, Vuillard ) rivisitati e prosciugati dei loro sughi più morbidi “. Per Guccione è ” artista autentico, il suo spirito creativo è sempre stato spirito astratto. I cavalli, gli acrobati, le figure di donna, non sono stati che un veicolo, un involucro su cui applicare I’elemento artìstico per interrogarsi nel mondo, per tendere verso I’ ignoto “.Per Scopello, ” nella sensualità spontanea della sua figurazione» esprime una straordinaria gioia dì vivere, ancor più evidente nella scelta cromatica : una polifonica festa di colori » vivaci e squillanti che balenano negli occhi e nel sorriso delle sue donne aggraziate. Anche i paesaggi e gli interni consentono a Brancato di comunicare la sua vena poetica che si avverte nell’ accurata distribuzione delle ombre « nella resa di atmosfere sfumate oppure fortemente assolate “. Occhipinti scrive di ” alchimie cromatiche ” e Spanò – Pitrolito Lo titola ” pittore della felicità “, per Nìfosì, i temi ricorrenti di Brancato sono ” giovani donne, paesaggi» nature morte. I volti femminili sono omaggi alla bellezza isolana : I’ incarnato è color mandorla, gli occhi splendono come carboni accesi » l’ acconciatura è esuberante, ostentata con modi iconografici spagnoleggianti alla Rubens, alla Velasquez. Nelle nature morte prevalgono elementi postimpressionisti, adatti ad una sensibilità affabile e innamorata della vita.
Per Civello, ” i momenti di più vaporoso vagheggiamento non sono certo per Brancato mitizzazione idìllica, ma individuazioni, decantate da ogni interesse polemico, di una verità contemplativa ” e , per Barra, ” nelle sue opere la passione sembra superata ma senza raggiungere alcuna idea di forma “.
. Nessun vincolo di parentela, se non artistico « lega il nostro ottantenne Biagio ai gemelli florìdiani – catanesi, Nino e Tano Brancato ne al pachinese – siracusano, Corrado Brancato , Art Director della Galle