Nei modi di dire e nei proverbi siciliani del passato il gatto domestico generalmente si indicava con la forma al femminile, senza specificare il sesso: Quannu ’a jatta nun pò jùnciri a la sajmi (per sincope del volgare SAGIMEN = strutto, grasso) dici ca feti; Quannu ’a jatta nun c’è ’i surci abballunu…, al contrario di altri animali come il topo o il cane che si indicavano al maschile: ’A jatta mi talìa e ’u surci mi nichìa (mi indispettisce, mi irrita. Dal francese NIQUE = disprezzo), ’Ssiri ’u cani c’’a jatta e così via.
Per la tradizione popolare il periodo di gestazione della gatta durava quanto quello dell’allattamento: ’A jatta tri misi porta e tri misi allatta.
Spesso le gatte assumevano il nome della loro Patrona, Santa Marta.
Per comunicare con loro si usavano delle voci onomatopeiche: Cci-chissi!, cci-chissi! Per scacciarle, Muci!, muci! o Mucidda!, mucidda (sta per micia o micetta) per farle avvicinare.
Sicuramente i gatti di una volta dai loro padroni non venivano trattati così bene come quelli di oggi, L’animali si trattunu d’animali si diceva. Avendo però la funzione di catturare i topi, a differenza di altre bestie, un certo privilegio l’avevano: si tenevano dentro casa e si davano loro, invece di buttarli, tutti i rimasugli dei pasti giornalieri. Questa consuetudine, se riferita all’uomo che usava dare in abbondanza ai propri simili oggetti di scarso valore, si indicava con l’espressione N’hanu avutu cani e jatti, cioè tutti. Invece quando ci si intestardiva a non volere fare alcuna concessione a chicchessìa si ribadiva: Nun cci nesci nenti p’’a jatta.
Nonostante si cibassero soltanto degli avanzi, i gatti domestici si ingrassavano facilmente, per questo le ragazze snelle, che spregiatamene venivano tacciate di eccessiva magrezza, difendevano la loro gracilità dicendo: ’A carni sta bona â jatta.
Guai a fare assaggiare ai gatti cibi saporiti, non si toglievano di dosso: A la jatta ca licca lu spitu (spiedo) nun cci dari carni salata. Riferito all’uomo, il proverbio consigliava di non affidare a qualcuno qualcosa di cui si sapeva che fosse smanioso di possedere. La facilità dell’organismo dei gatti di assimilare il cibo è testimoniata dall’antica usanza di tagliare loro nelle prime settimane di vita il ciuffetto di peli posto all’estremità della coda detto scialanca (Dal francone CHÂLE, a sua volta dall’hindi SHAL, pronuncia sciaal = drappo con frange + HANKA = parte posteriore del corpo.) Si credeva che se non venisse reciso i gatti sarebbero diventati insaziabilmente voraci.
Il rapporto per niente affettuoso tra uomo e gatto ha dato origine a diverse locuzioni proverbiali oggi desuete. ’Ssiri ’na jatta significava essere litigioso, pronto a graffiare, per cui si raccomandava di Nun pigghjari jatti ’n vrazza (nelle braccia) e di non accarezzarli: A li jatti cchiù l’allisci, cchiù la cura cci crisci, un detto che in senso figurato vuol dire: A certa gente più si fa del bene e più si è ricambiati con il male. La stessa accusa di ingratitudine è contenuta nel modo di dire Fari ’u panicottu (in provincia ’a minestra) a li jatti che, metaforicamente, significa: è inutile affaticarsi per gli altri.
Addirittura di quelle persone che, anche quando credevano di fare del bene facevano del male, si diceva Fannu comu ’a jatta ca quannu accarizza sgranfugna (graffia. Letteralmente affonda le granfie, cioè gli unghioni; dal longobardo KRAMPF = uncino + l’epitesi verbale. La S in questo caso ha valore intensivo).
E a proposito di graffiare, anche la donna siracusana veniva identificata con la gatta: ’A sarausana è comu ’a jatta, prima t’alliscia e poi ti ’ratta (gratta).
I proverbi e i modi di dire del passato mettevano in risalto più i difetti che i pregi dei gatti. Come per i cani, così anche per i gatti, sconsigliavano di tenere in casa quelli rossicci che ingiustamente erano considerati inaffidabili: Di pilu russu né cani, né jatti. Dare a qualcuno l’epiteto di Testa (o mirudda = midolla) di jatta significava accusarlo di non avere cervello.
Si è esagerato o si è voluto generalizzare nel definire la gatta un animale puzzolente (Di lu fetu di la jatta lu diavulu si scantau) così come non risponde al vero che tutti questi animali si lamentassero sempre, anche quando avevano la bocca piena di cibo buono: Fari comu la jatta ccu lu purmuni (carne, letteralmente polmone) ’m mucca. Sicuramente il detto trae origine dall’opportunità di biasimare il comportamento di quelle persone che non sono mai contente, neanche quando hanno tutto.
Un senso di predestinazione è contenuto nel proverbio Cu’ è figghiu ’i jatta, surci ha’ pigghiari
con cui si era soliti indicare, più con compiacimento che con rassegnazione, le fanciulle che seguivano le madri sulla cattiva strada (’a via di l’acìtu).
Che non bisognasse aver fretta negli affari o nelle cose importanti era rilevato da un adagio che ha il corrispondente nella lingua italiana: ’A jatta priscialora (frettolosa, da PRESCIA, a sua volta dal latino parlato PRESSIAM = fretta) fa ’i jattareddi (o ’i figghi) orbi. Con il termine jattareddi, oltre ai gattini, i nostri anziani, medici di famiglia compresi, chiamavano, perché avevano lo stesso suono, i sibili che gli asmatici e chi era affetto da bronchite emettevano per difficoltà di respirazione, però ’i jattareddi raperu l’occhi si diceva di quelle persone che si erano scaltrite e non si lasciavano più ingannare.
Alcune locuzioni proverbiali che mettevano in evidenza gli aspetti positivi, ma sarebbe meglio dire le abilità, di questo animale domestico si usavano in senso metaforico per fare rilevare le capacità o la furbizia di alcune persone.
Di chi usciva sempre bene da situazioni difficili o mostrava di possedere una vitalità eccezionale si diceva: Havi setti spiriti comu ê jatti. Il numero sette nelle espressioni popolari ha carattere sacrale e sta ad indicare una misura indeterminata.
Un modo di dire, equivalente a quest’ultimo nel significato, è: Càdiri sempri â dritta comu ê jatti. Esso trae origine dalla capacità innata dei gatti di correggere la posizione del corpo durante le cadute da altezze notevoli uscendone indenni o tutt’al più riuscendo a riportare solo danni minimi.
Un altro privilegio di questo felino è costituito dagli occhi particolari. Riferita a certe persone, l’espressione Avìri occhi ’i jatta sottintende la capacità del gatto di adattare, dilatandola o restringendola, la pupilla (lineare di giorno, ovale di notte), riuscendo a vedere anche di notte al buio quando il comune occhio umano non distingue nulla.
Nella nostra tradizione popolare il gatto era anche simbolo della frode. La locuzione Fari ’a jatta morta allude al modo con cui questo animale quando vuol catturare una preda si mostra mite, fa finta di non vedere o addirittura si distende come se fosse morto per poi sorprendere con un balzo improvviso la vittima predestinata. Questo modo di dire siciliano ha il corrispondente italiano nel detto “Qui gatta ci cova” che equivale a: qui c’è sotto un inganno.
A Ferla, a chi per non compromettersi faceva lo gnorri, fingendo di non capire o di non sapere niente, si rivolgeva il detto Nun fari ’a jatta ’n cucuzza (letteralmente: non fare il gatto nella zucca) che equivale a quello siracusano Nun fari ’u babbu ppi’ nun pajari ’u daziu.
E concludo con un augurio: spero che a leggere questo articolo siano di più dei miei soliti quattru jatti.
Jatti e jattareddi

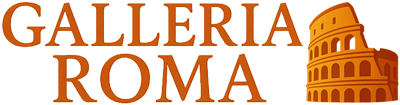
Lascia un commento